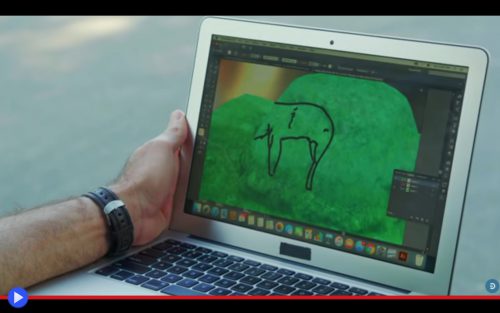Attorno alla metà del XIX secolo, un uomo della tribù nativo americana degli Cheyenne viaggiava lungo le ampie valli disabitate dello stato del Wyoming. Quando per riuscire temporaneamente a ripararsi dal sole, scelse di accamparsi sotto l’imponente butte (collina solitaria) di Matȟó Thípila, ovvero letteralmente nella sua lingua “La Tenda dell’Orso”. 386 metri di roccia monolitica sopra il corso del fiume che l’uomo bianco aveva scelto di chiamare arbitrariamente Belle Fourche, così come una tale svettante caratteristica del paesaggio aveva ricevuto l’appellativo, per una traduzione approssimativa e inesatta, di Torre del Diavolo, con riferimento alla nemesi del Dio cristiano. Esausto per il viaggio, l’uomo decise quindi di dormire per qualche ora, accampandosi vicino al teschio sbiancato di un bisonte, che in circostanze poco chiare aveva finito per trovarsi accatastato ad uno degli imponenti depositi di ghiaia e pietrisco alla base della formazione vagamente simile alla base di un grande tronco di pietra, cui la natura aveva chiesto di scomparire. “In questo luogo sacro, e non del tutto benevolo” pensò il viaggiatore “lo spirito totemico avrà cura di custodire la mia presenza.” E senza ulteriore preoccupazioni, scelse di abbassare le palpebre diventate così pesanti. Trascorsa qualche ora e giunto l’attimo del suo risveglio, tuttavia, una scoperta terribile minacciò di lasciarlo immobile per la paura: durate il suo stato d’incoscienza, infatti, una forza misteriosa l’aveva trasportato sulla sommità dell’impraticabile Matȟó Thípila, assieme al cranio dell’animale su cui tanto aveva fatto affidamento. Incerto su come procedere per ritornare a terra, il viaggiatore trascorse un intero giorno senza acqua né cibo, esposto a tutta l’inclemente furia degli elementi. Finché alla ricerca di un tenue appiglio, con un’ultima preghiera nei confronti della Grande Medicina, non poté far altro che addormentarsi nuovamente, ben sapendo che soltanto un ulteriore intervento sovrannaturale avrebbe potuto riuscire a salvarlo. Trascorsa la notte, il viaggiatore aprì di nuovo gli occhi per scoprire di essere tornato alle radici della grande pietra. E quando li volse verso l’alto, scorse il teschio di bufalo in bilico sul ciglio della sommità, unica prova della sua avventura senza nessun tipo di spiegazione apparente. In quale altro modo, dopo tutto, un tale resto animale avrebbe potuto raggiungere la cima di Matȟó Thípila, dove nessun altro piede del tutto umano si era posato fino al giorno precedente?
Nessun piede umano, s’intende, fatta eccezione per quello di un gruppo di ragazze all’origine dei tempi, che inseguite fino a questo luogo dalla massa ciclopica di un orso leggendario, salirono la grande roccia verticale come si trattasse di un’autostrada, per poi pregare il Dio creatore Maheo, detentore della Grande Medicina, affinché potessero raggiungere in qualche modo la salvezza. E fu così che, mentre il feroce carnivoro incideva profondi solchi con gli artigli in quella che sarebbe diventata folkloristicamente la sua eterna dimora, esse vennero trasportate in cielo dalle Sue aquile, venendo trasformate nelle stelle delle Pleiadi remote. Ma la roccia, guadagnatosi una fama imperitura, sarebbe lì rimasta a perenne monito delle generazioni future. Così che leggende simili si trovano in una complessa gestalt nel repertorio delle diverse tribù di questo stato, tra cui i Sioux, i Kiowa ed i Lakota, mentre l’esistenza del butte sarebbe diventata nota agli europei fin dalle remote esplorazioni, effettuate dai cacciatori e possessori di trappole intenti a trarre sostentamento dalle vaste terre selvagge americane. I quali senza alcun’esitazione avrebbero affermato, già da allora, che la Torre non fosse l’opera di grandi spiriti o altre creature irragionevoli, bensì frutto delle operose mani del più temibile tra gli angeli decaduti, Lucifero che regna nel profondo sottosuolo presso cui vengono inviate le anime dannate dei viventi. Entrambe interpretazioni destinate a passare in secondo piano, o per lo meno essere subordinate, di fronte all’interpretazione contemporanea della scienza! Che vede tale orpello paesaggistico come la mera conseguenza di un’intrusione magmatica attraverso gli strati della crosta terrestre, sebbene in circostanze ed un’epoca tutt’ora incerte…
luoghi
L’isola di pietre dov’è stata disegnata l’impronta digitale del mondo
Giganti che abitavano codesto mare; oppure, se vogliamo essere precisi, dei veri e propri titani. Esseri i cui piedi misuravano l’ampiezza delle strade, ed i capelli sconfinavano tra le propaggini biancastre delle nubi. Per cui tempeste, o terremoti, altro non erano che timidi sussulti delle circostanze. Ed il cui approccio funzionale alla risoluzione dei problemi, consisteva solamente nell’avvicinarsi ad un qualcosa, e toccarlo. Qualche volta in modo filosofico, attraverso l’elaborazione della volontà. Certe altre, premendo a fondo per plasmare queste forme a propria guisa ed aspetto, imitando l’approssimazione esistenziale degli Dei. Altrimenti, come mai potremmo avvicinarsi a dare un senso a tutto questo? Con la forma di un’ellissoide vagamente somigliante a una patata, l’isola di Bagnevaz (o Bavljenac in lingua locale, o ancora per gli anglofoni Bagnevaz) si trova collocata ad ovest di Sebenico, nell’omonimo arcipelago presso i confini mediani dell’Adriatico croato. Appena 0,14 Km quadrati, circondati da una spiaggia sottile ed occupati da una vegetazione piuttosto rada e separata da una serie di barriere. Che non avrebbe invero alcuna caratteristica degna di nota, se non fosse per il piccolo “dettaglio” dei 1430 metri di muri a secco che ne circondano e percorrono l’entroterra, delimitando una grandissima serie d’ambienti, capaci di avvicinarsi esteriormente all’aspetto presumibile di un labirinto. Il che, aggiungendo all’equazione l’effettivo aspetto dell’intero paesaggio visto dall’alto, finisce per ricordare a sua volta l’aspetto di un’impronta digitale dalle proporzioni niente meno che monumentali. La cui presenza, tralasciando transitorie ipotesi di tipo folkloristico, avrebbe potuto sconcertare particolarmente gli scienziati alla ricerca di antiche civiltà o studiosi degli eventi fuori dal contesto, se non fosse stato per l’apprezzabile dislocazione nell’intero territorio di un’ampia serie di luoghi similari, sebbene dalla forma meno suggestiva d’ipotetiche presenze spropositate. Trattasi, nello specifico, di esempi del cosiddetto dalmatinski suhozid o “muro a secco dalmata” importante linea guida architettonica funzionale alla delimitazione, protezione e consolidamento dei terreni agricoli, talvolta capace di prendere la forma di veri e propri terrazzamenti, utili a massimizzare l’area coltivabile di un paese non sempre fertile in maniera sufficiente a favorire gli interessi dei suoi abitanti. Ma che in casi come questo, letteralmente privi di un’elevazione al di sopra di pochi metri dal livello del mare, finisce piuttosto per assumere la funzionalità di una barriera nei confronti del vento, oltre all’unico sistema attraverso cui la letterale copertura di pietre che caratterizzano il paesaggio può essere impiegata con un fine utile, conseguente dall’appropriato accumulo poco prima di sotterrare i semi delle proprie piante.
Chi ha costruito Bagnevaz, dunque, e perché? La risposta breve è che nonostante la memoria storica dei locali appaia avere delle idee piuttosto chiare in merito, l’informazione non parrebbe aver trovato una casa sicura su Internet, dove il “mistero inspiegabile” e “l’eccezionale aspetto” dell’antico territorio agricolo croato parrebbero aver sovrascritto nel tempo ogni approccio razionale all’intera faccenda. Raccogliere e confrontare le fonti, oltre all’uso della logica in merito alla vicenda umana di questa regione, può permettere il parziale accesso ad un sentiero esplicativo piuttosto valido. Quello che vedrebbe la piccola terra emersa come uno spazio di sostentamento per le molte comunità costiere nate in bilico tra il XIX e il XX secolo, quando il dominio e la tassazione dell’Impero Ottomano, ancor prima dello scoppio della prima guerra mondiale, aveva spinto molti abitanti dell’entroterra a trasferirsi in località il più possibile remote. Praticando in questo sito specifico, a quanto sembra, la coltivazione particolarmente redditizia della vite vinicola, in un periodo durante il quale varie pandemie agricole avevano creato un vuoto nel vasto mercato enogastronomico dell’Impero Austro-Ungarico al di là dello stretto mare. Almeno finché qualcosa d’inaspettato e imprevedibile, ancor peggiore di qualsiasi guerra, non avrebbe finito per costare molto caro ai possessori di questi campi. L’arrivo, sulle disabitate coste, dei conigli…
La maledizione del mammut nel misterioso triangolo lacustre nordamericano
“Ciò che è iscritto nella pietra, in essa resta intrappolato. Lo spirito dell’animale non potrà tornare a vendicarsi.” Questo disse il capo della battuta di caccia, mentre impugnando lo scalpello con punta intercambiabile di selce, guardò con occhio critico la sua creazione, quindi nuovamente l’ingombrante carcassa, che già i cacciatori stavano suddividendo in pezzi maggiormente trasportabili, verso l’affamato accampamento di Gerenesee. Davvero inaspettato, che si debba essere giunti a tanto. E certamente un pessimo comportamento, dinnanzi al totemico giudizio degli Dei anziani. “Pinga, grande cacciatrice; Sedna, signore dell’Oltretomba; Torngasoak del cielo ed Igaluk della Luna. Ascoltate la mia preghiera.” E qui, con una pausa di sicuro effetto, l’uomo infisse la sua lancia nella terra friabile della grande valle di Missaurakee. Loro ben sapevano, o così sperava, come le genti di Michigan non uccidessero di solito la Grande Proboscide del Settentrione. Ma più che altro l’agile animale dalle corna simili ad un ramo arboricolo, che un giorno ancora assai lontano l’uomo avrebbe scelto di chiamare caribù. “Poiché… La stagione è stata difficile.” Continuò “Il clima, infausto. Oggi doveva concludersi l’ultima grande corsa, prima del calare e del ghiaccio senza limiti diurni. E se fossimo tornati senza provviste, molti dei membri più giovani ed anziani della tribù vi avrebbero raggiunto nella vostra grande sapienza.” Apparentemente soddisfatto, il condottiero della battuta impugnò nuovamente la sua arma. Con un gesto semplice, la tirò fuori dal terreno per volgere lo sguardo ai suoi sottoposti. Ciascun cacciatore mostrava un grado differente di rammarico, sebbene tutti, tra coloro che non erano impegnati nello smembramento, mostrassero anche un’espressione ragionevolmente determinata. E fu allora che all’altro capo della valle, sembrò risuonare un barrito distante…
“C-capitano, cos’è stato questo suono?” Il giovane mozzo Adams si rivolse all’uomo che si trovava al timone, nel compatto trasporto di legname di ritorno verso la segheria di Hackey-Hume nel territorio di Muskegon. Animali senza nome in terre oltre la fitta nebbia, isole del tutto impossibili lungo quello specifico tratto di mare. Poiché tale non era in fin dei conti, bensì l’acqua familiare di un profondo e tanto spesso, gelido lago. “A dire il vero ragazzo mio, sembrava proprio un elefante.” Rispose l’unico ufficiale a bordo, se così si poteva chiamare, da sotto la folta barba bianca ed il cappello indicativo del suo ruolo. Era il 21 maggio del 1891, una data destinata a rimanere iscritta nella storia… Come l’inizio di una lunga e articolata serie di tragedie. Destinata a culminare, esattamente 59 anni dopo, nella scomparsa di un intero aereo passeggeri con più di 80 persone a bordo. In un particolare tratto di quel Grande Lago, capace di disegnare la forma riconoscibile di un triangolo, tra i vertici topografici di Manitowoc in Wisconsin, verso est a Ludington ed infine nella punta sud di Benton Harbor, entrambi entro i confini dello stato del Michigan. Tutto questo era naturalmente inimmaginabile per i sette marinai della Thomas Hume, che in quel giorno predestinato sarebbero stati inghiottiti dalle acque del lago senza lasciare nessun tipo di traccia, assieme al loro intero vascello. Per una motivazione, ed a causa di una serie d’eventi, che avrebbe lasciato molto a lungo perplessi anche i maggiori esperti sull’argomento.
E i misteri, si sa, tendono a generare mostri. Particolarmente nei frangenti in cui possono trovarsi associati a situazioni archeologiche tutt’altro che chiare, causa il ritrovamento di un qualcosa che nessuno, tra i viventi, può riuscire realmente ad associare a fatti precedentemente noti. Il fatto è che a seguire quel primo disastro marittimo, ce ne sarebbero stati molti altri: il lussuoso battello a vapore Lady Elgin, nel 1860, che finì per naufragare dopo l’urto contro un’imbarcazione più piccola costando la vita di 300 persone. La Rouse-Simmons, che trasportava alberi di Natale verso Chicago nel 1912, di nuovo scomparsa senza lasciare traccia e per cause del tutto incerte. La Carl D. Banks, che si spezzò a metà nel 1958. Tutti relitti destinati ad essere molti anni dopo ritrovati, diventando a loro modo tristemente famosi e portando all’istituzione informale di una sorta di macabro turismo con le bombole e gli occhiali da immersione, a sua volta conduttivo verso il prelievo diretto di una lunga e inappropriata serie di “souvenir”…
L’anatomia policroma del delta dello Yukon, polmone dell’America boreale
Nelle oscure profondità dell’edificio di medicina, alcune delle più influenti personalità dell’Università di Heidelberg erano giunte per assistere all’esperimento. Il giovane ricercatore Gunter von Hagens, nel corso dell’intero 1977, aveva redatto testi, e pubblicato articoli, in merito a una sua speciale invenzione tecnica, capace di lasciare molti senza parole. Ma in quel giorno, in quel momento, era finalmente giunto il momento della verità. Spettatore silenzioso sopra la barella al centro del teatro anatomico, il corpo ormai privo di vita di uno dei molti senzatetto della Germania Est, volontariamente “donato” alla scienza nel momento estremo della sua dipartita. Ora il promettente anatomopatologo, già detentore di svariate pubblicazioni di fama internazionale, descriveva ancora una volta i passaggi successivi della sua invenzione, attraverso cui avrebbe creato il più impeccabile modello di studio del sistema venoso umano. Terminato il breve discorso, girando attorno alla pompa della resina, impugnò il pesante tubo a Y, che con procedette quindi ad inserire rispettivamente nell’esofago e nella trachea del paziente. Senza troppa gentilezza, né forza eccessiva, avendo fatto pratica per più e più volte, prima di procedere all’accensione così lungamente attesa del suo meccanismo. Tecnologia, magia, qual è la differenza? Pensò sommessamente tra se e se, mentre il processo di plastinazione raggiungeva l’apice di quel momento straordinariamente significativo. Ora sarebbero dovute trascorrere ore, o giorni, prima di poter procedere al passaggio successivo. Ma come in un programma di cucina per la Tv, Hagens aveva già preparato un secondo cadavere, posizionato su di una barella accanto al suo malcapitato collega. Con un gesto magniloquente, dunque, tirò la leva per attivare il sistema elevatore che l’avrebbe immerso all’interno di una grande bacinella in fibra di vetro. Ricolma, per l’occasione specifica, di una copiosa quantità della sua speciale miscela d’acetone. Ora i minuti trascorsero lunghi minuti e quasi un’ora, mentre il processo di corrosione chimica si svolgeva secondo il copione attentamente prefissato. Hagens utilizzò il tempo per spiegare nuovamente come fosse giunto a quel processo, finché non seppe che si era arrivati ormai al suo miracoloso compimento. Ecce homo, sussurrò trionfale, tirando su con estrema cautela il soggetto finale della procedura. Con la sua testa ormai priva di bulbi oculari (un paio di biglie di vetro sarebbero servite allo scopo) la muscolatura pienamente visibile, ma soprattutto, ogni singolo canale venoso ed arteria perfettamente messo in evidenza, grazie a una vera e propria ragnatela di colori scelti per il massimo contrasto visuale. Mentre i presenti osservano con attenzione il risultato, già un mormorio diffuso cominciò a diffondersi tra i capannelli di esperti al vertice dei rispettivi settori. Ma fu quando la prospettiva permise finalmente di scorgere il risultato ottenuto sui polmoni del cadavere, che un applauso si concretizzò spontaneamente tra gli spalti: esofago, bronchi e bronchioli, fino ai più infinitesimali capillari ed alveoli di quelle sacche d’aria, gloriosamente spalancate innanzi allo sguardo indagatore dei viventi. Qualcosa di straordinariamente ordinario come la morte, oggi, aveva finalmente dato i suoi frutti eccezionali, che sarebbero durati per lungo, lunghissimo tempo.
Che la Terra sia essenzialmente condannata a deperire, scolorendosi fino alla sua imperterrita ed inevitabile dipartita, è un concetto largamente dato per inevitabile dalla cultura della nostra epoca post-moderna. Mentre rassegnati a un simile destino, sfruttiamo fino all’ultima risorsa di cui possiamo ancora disporre, nella speranza di riuscire un giorno a sviluppare il viaggio interstellare. Il che del resto non preclude, a questa umanità così drammaticamente simile a un’infezione virale, di compiacersi di ciò che ancora riesce a possedere, tramite l’inquadratura di una telecamera lanciata a molti metri al secondo, molte migliaia di chilometri sopra la linea dell’orizzonte. Landsat 8, questo il nome dell’artista, se tale può essere davvero definito uno strumento senza nessun tipo di cervello come la scatola lanciata dalla Nasa, nel corso di un’utile missione, a unirsi alla moltitudine di oggetti in orbita terrestre asincrona, con la finalità di realizzare il più alto numero possibile di panorami utili a commemorare la già sofferente natura. E farlo questa volta, rispetto all’opera dei suoi sette predecessori (non tutti altrettanto destinati al successo) tramite l’impiego dello speciale sensore Operational Land Imager (OLI) dotato di 7.000 sensori per ciascuna banda dello spettro cromatico, anche al di là della parte osservabile dell’occhio umano. Qualcosa che permette di mettere in evidenza, volta per volta, immagini capaci di mettere in evidenza la Vera Realtà, senza passare per il filtro spesso soggettivista del cosiddetto senso comune. In casi come quello sperimentato lo scorso maggio, quando l’apparecchio venne puntato, in una serie di passaggi successivi, presso il maggiore e più importante delta dell’intera America settentrionale. Nonché uno dei più vasti, ed atipici, dell’intero pianeta…