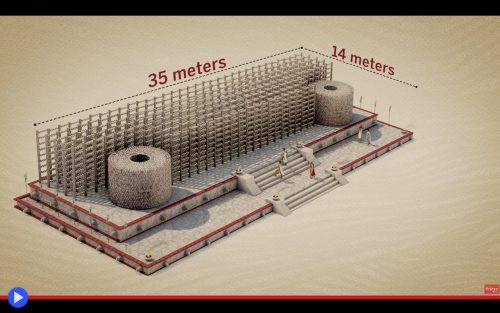Le opere architettoniche del passato possono venire spesso collocate lungo un asse lineare, dove gli edifici di maggior rilievo ed imponenza devono aderire a dei particolari canoni esteriori e funzionali, dettati dal senso comune che determina il flusso di risorse e forza lavoro. Laddove all’altro capo dello spettro, trovano collocazione le opere vernacolari imprevedibili o realmente spontanee, difficilmente in grado di oltrepassare le dimensioni di una residenza di famiglia o il monumento costruito da una piccola comunità rurale. Nel caso in cui il potere assoluto risieda nella visione e il gusto di un singolo individuo, tuttavia, ogni cosa può riuscire a palesarsi, a patto di disporre di maestranze dalle capacità sufficientemente navigate. E nessuno potrebbe dubitare che nella contea cinese di Chongqing, durante il regno dell’Imperatore Xianfeng dei Qing (1831-1861) simili speciali condizioni avessero trovato il modo di convergere a tutti gli effetti. Come reso evidente dall’antico complesso in pietra di Shibaozhai (石宝寨 – Preziosa Fortezza di Pietra) lungo il fiume Yangtze, destinato a ricevere una mistica “pagoda” di nove piani dalle caratteristiche pareti rosse e finestre circolari. Per cui le virgolette appaiono del tutto motivate, giacché una tale classe d’edifici tendono generalmente a prevedere una pianta ottagonale o quadrata, oltre ad uno spazio tutto attorno per riuscire ad ammirarne l’altezza. Laddove qui siamo di fronte ad un costrutto che si appoggia e al tempo stesso fa un sapiente impiego della ripida collina retrostante, un rilievo dell’altezza di 200 metri con in cima il tempio dedicato al bodhisattva Manjusri. Essendo giunta a costituire, nei termini coévi, l’iconica Piccola Penglai (蓬莱山) o Terra Mistica degli Immortali ma anche una versione antesignana con le sue ripide scale degli odierni ascensori montani, largamente utilizzati in epoca contemporanea per permettere ai turisti di apprezzare alcuni dei panorami più eccezionali della Cina. In sostituzione dell’antico metodo secondo cui, per lunghi secoli, i visitatori di tale luogo avrebbero dovuto arrampicarsi su un ripido sentiero aiutandosi con una lunga catena. Nessuno aveva mai pensato, d’altra parte, che un luogo simile al tempo del su primo utilizzo potesse costituire un giorno l’attrazione turistica principale della sua intera regione, nonché un patrimonio classificato al più alto livello del repertorio nazionale…
templi
Il grande fiore di cemento che ospita la casa della religione universale a Nuova Delhi
Amore per la Terra e tutto ciò che vi abita, le innumerevoli creature striscianti, volanti e che nuotano nelle acque dei profondi oceani tra i continenti. Nonché i plurimi cespugli, l’erba e gli alberi, della metà vegetativa della biosfera, intesa come strato verde o variopinto ogni qual volta inizia la stagione della fioritura. E se invero ci sovrasta un grande Essere, al tempo stesso demiurgo e sorvegliante di quest’universo, non sarebbe forse giusto offrirgli un piedistallo costruito nella “Miglior guisa possibile nel mondo materiale” come scrisse chiaramente tra gli altri ʻAbdu’l-Bahá, il figlio e successore del profeta iraniano Baháʼu’lláh (1817-1892) supremo fondatore della religione dei tempi moderni che prende il nome di Fede Baháʼí. I cui molteplici edifici sacri in giro per il mondo riflettono l’idea fondamentale di apertura verso le visioni di ogni provenienza filosofica e culturale, presentando l’iconica forma a nove lati con nove aperture oltre all’assenza di un pulpito definito, permettendo e addirittura incoraggiando la lettura in ciascun angolo di qualsivoglia testo sacro esistente. Da cui una serie di precetti e accorgimenti che, a partire da periodo della guida spirituale di ʻAbdu’l-Bahá, avrebbe costituito il fondamento di opere architettoniche di chiara distinzione tra cui d’altronde, nessuna appare destinata a rimanere parte del patrimonio estetico globalizzato più del Kamal Mandir (“Tempio del Loto”) a Nuova Delhi, capace di rientrare tra i più complessi e distintivi punti di riferimento costruiti tramite uso estensivo del cemento armato.
Un tempio circolare nella capitale indiana dal diametro di 70 metri e l’altezza di 34, sovrastato da un tetto composito formato da 27 petali parzialmente sovrapposti, la cui funzionalità primaria è quella di riuscire ad evocare l’idea del genere acquatico Nelumbo, pianta galleggiante le cui infiorescenze rosa vengono considerate sacre dal canone religioso di molti paesi dell’Asia. Creazione concepita a partire dal 1976 dall’architetto di origini iraniane, oggi residente in California, Fariborz Sahba che prima di presentare il suo progetto ai committenti, si dice avesse viaggiato in lungo e in largo per l’intero subcontinente al fine di acquisire le linee guida estetiche destinate a dominare la sua eccezionale idea. Approdando per lo meno in modo metaforico anche nei distanti territori australiani, se è vero che il suo indiscutibile capolavoro presenta più di un singolo punto di contatto con il Teatro dell’Opera di Sydney inaugurato soltanto tre anni prima, il cui profilo esterno mostra soluzioni tecnologiche non così distanti dal progetto indiano…
L’intero canone buddhista nelle statue policrome del tempio dell’Acqua e della Terra
In una delle scene maggiormente memorabili del recente videogioco cinese Black Myth: Wukong, il protagonista liberamente ispirato al personaggio letterario del Re Scimmia combatte contro Ciglio Giallo, entità demoniaca che ha trovato il modo di assumere l’aspetto del Buddha. Il difficile incontro, che richiede una conoscenza approfondita dei comandi ed i poteri del protagonista, si svolge all’interno di un tempio titanico, finemente ornato di maestose statue sovrapposte l’una all’altra, come un attento e immoto pubblico di personaggi senza una voce. Come molte altre sequenze e momenti dell’opera interattiva, l’ispirazione artistica è particolarmente precisa e fa riferimento ad un luogo specifico del grande Regno di Mezzo. Il tempio di Shuilu (水陆庵 – letteralmente: dell’Acqua e della terra) costruito per prima volta nella tarda epoca delle Sei Dinastie (V sec. d.C.) ma che avrebbe trovato principalmente nelle successive epoche dei Tang e Ming le ragioni più valide della sua imperitura magnificenza. Particolarmente dopo l’intervento diretto del principe Zhu Huaijuan che attorno all’anno Mille qui nello Shaanxi ebbe la sovrintendenza del regno vassallo di Qin, da lui sfruttata per accumulare meriti religiosi per se stesso e la sua intera famiglia. Tramite la costruzione di un santuario le cui proporzioni artistiche, semplicemente, esulavano da cognizioni pregresse all’interno dell’intero vasto Impero cinese. Sua fu dunque l’idea di riprendere per lo Shuilu situato 60 Km ad est di Xi’an, da lui ribattezzato in Shuilu’an, il tema iniziato dal celebre scultore di due secoli prima Yang Huizi, che aveva ornato la grande sala centrale con molteplici sculture vivaci ed animate del Buddha, mediante il coinvolgimento di numerosi artigiani provenienti da ogni angolo della nazione. Ciascuno incaricato, mediante l’applicazione di un piano preciso, nel curare un diverso angolo di una composizione di centinaia, poi un migliaio e infine 3.700 statue differenti, disposte in una pletora di affascinanti composizioni e differenti modalità espositive. Principalmente realizzate in terracotta dipinta, come si usava fare all’epoca, i loro soggetti includono santi e saggi, divinità, uomini e donne impegnati nella raffigurazione d’importanti episodi nella vita di Sakyamuni, ma anche favole o novelle di derivazione popolare, in quella che costituisce una vera e propria enciclopedia visuale di tutto quanto fosse mai stato detto a beneficio della consapevolezza individuale e la salvezza esistenziale dei fedeli. Un letterale viaggio ritroso, ma anche di lato e verso il punto di fuga prospettico, nel caratteristico e stratificato mondo della religione cinese…
Le sessantamila paia di orbite sospese nei crani del defunto popolo di Tenochtitlan
Dalle vette della nostra rastrelliera, un grido collettivo fu il nostro silenzioso contributo alla fine del mondo. Senza labbra, senza occhi, senza lingua e neanche l’ombra di un cervello, il destino ci aveva riservato un posto in prima fila nel momento in cui una situazione in bilico raggiunse il punto critico d’ebollizione. Per volere ed ordine di Pedro de Alvarado, il vice del “civilizzato” conquistador Hernán Cortés, partito per la costa al fine di trovare un accordo con gli spagnoli giunti al fine di arrestarlo, ponendo fine alle sue operazioni di agente della corona. “Per difenderci dal palesarsi di un complotto, finalizzato alla nostra sistematica e rituale eliminazione.” Avrebbero affermato loro; “Per cupidigia e l’avidità indotta dal desiderio di sottrarci i nostri tesori.” Giureranno successivamente i pochissimi sopravvissuti del clero Azteco, imprimendo le proprie testimonianze in lingua Nahuatl, su pelli di animali, stoffa, corteccia di fico. Ma se qualcuno ci avesse chiesto di riferire la nostra impressione, non ci fu un singolo motivo scatenante. Bensì la temperatura gradualmente più elevata, di un luogo letteralmente intriso di sangue che altro ne bramava così come fatto in precedenza lungo il ciclo ininterrotto delle stagioni. Chi, meglio di noi, poteva dire di averne una chiara consapevolezza?
Era, dunque, il 22 maggio del 1520, quando nel corso della festa di Toxacl indetta dall’imperatore Montezuma, per celebrare ogni anno il dio Tezcatlipoca, un gruppo di stranieri nelle loro impenetrabili armature, con fucili, spade e lance, alla testa di una folla di mexica inferociti, bloccarono ogni uscita del Templo Mayor, principale luogo di culto della capitale. Per poi dare inizio, cupamente, al massacro. Centinaia, migliaia di membri della casta nobile e sacerdotale… Nel giro di poche ore, trasformati in stolidi cadaveri, avvicinando l’ora in cui l’eterno impero avrebbe visto la sua stessa struttura rovesciata, smembrata e fatta a pezzi così come in anni precedenti, era toccato a noi ed alle nostre famiglie oggetto dell’onore più terribile tra tutti quanti: nutrire gli spiriti divini del cielo e della terra. Questa, la nostra testimonianza di esseri immortali, le nude teste in alto sulle torri circolari dello Huey tzompantli, svettante collezione dei crani. Tale il nostro senso d’esultanza, per la catarsi distruttiva di coloro che, attraverso le generazioni, era stato fatto ai danni di noialtri, colpevoli soltanto di essere venuti al mondo in un paese dominato da una religione assetata di violenza ed uccisioni. Cessate le grida, disperso il fumo, gli spagnoli presero quindi lo stesso Montezuma in ostaggio, prima di ritirarsi nella foresta in attesa del ritorno del loro condottiero. Una decina dei loro, rimasti tra i morti della frenetica battaglia, vennero decapitati, le loro teste scarnificate ed essiccate. Prima di venire aggiunte, con tanto di barba, alla “gloriosa” rastrelliera dei testimoni…