Forse uno degli oggetti più notevoli ad aver mai trovato collocazione all’interno di un hangar avrebbe fatto la sua comparsa in una struttura designata in quel di Weeksville, North Carolina, nell’inverno del 1964. In maniera totalmente inaspettata e improvvisa per tutti coloro non fossero stati coinvolti direttamente nella sua preparazione, quando un pallone in poliestere riflettente della massa di 256 Kg sarebbe stato riempito d’aria con un ritmo sostenuto, fino all’ottenimento di una sfera perfetta dal diametro di esattamente 41 metri. Argentata e magnifica, svettante come una sorta di manufatto alieno fuori dal contesto frutto di un contatto interdimensionale segreto, essa costituiva nella realtà dei fatti un oggetto dalla chiara funzionalità pratica, frutto di un piano ben preciso ed attentamente pianificato. Con radici risalenti ad almeno 6 anni prima, quando nel corso di un incontro sul tema dei satelliti per le telecomunicazioni l’ingegnere John R. Pierce, della compagnia telefonica Bell, ipotizzò l’eventualità d’impiegare un oggetto costruito dall’uomo come riflettore passivo per i segnali audio e video, permettendo ai relativi segnali di oltrepassare il bordo della curvatura terrestre. Idea che piacque a tal punto, in modo particolare al direttore del Jet Propulsion Laboratory californiano William H. Pickering, che entro il mese di ottobre di quell’anno venne designato dall’esercito statunitense un gruppo di tecnici incaricati di trasformarlo in realtà. Nel frattempo il JPL era passato sotto il controllo del nuovo ente governativo della National Aeronautics and Space Administration (NASA) ed aveva avuto inizio, formalmente, il programma spaziale degli Stati Uniti.
Reduci dell’esperienza dello Sputnik-1 sovietico, mandato in orbita nel 1957 ed un’intero anno prima dell’Explorer-1 americano, la superpotenza occidentale non aveva la benché minima intenzione di essere raggiunta o superata anche nel campo delle telecomunicazioni condotte mediante oggetti sospesi nello spazio cosmico esterno. E fu così che entro il 1960, il prototipo del cosiddetto progetto Echo, numero Cospar internazionale 6000901 fu pronto; il suo diametro era pari a 30 metri ed il materiale costituente, come quello dei successivi modelli, costituito principalmente in polietilene tereftalato (PET) schiacciato ed espanso, fino al punto di costituire una membrana spessa, flessibile e resistente. Una soluzione altrimenti identificabile con il suo nome commerciale di Mylar, che oltre alle caratteristiche strutturali presentava anche la dote niente affatto trascurabile di una colorazione argentea resistente al vuoto cosmico, idealmente perfetta per la realizzazione del fine originariamente auspicato. Come desumibile dal nome dei satelliti in questione, l’idea fondamentale era quella di utilizzare la grande sfera come una sorta di riflettore catarifrangente, capace non soltanto di restituire la stragrande maggioranza della luce ricevuta dall’astro solare, ma anche il 97% stimato delle microonde frutto dei segnali radio terrestri. Forse il modo più semplice e funzionale di far rimbalzare una trasmissione, se non che il più grave dei contrattempi si trovava purtroppo in agguato. Quando il 13 maggio del 1960, a causa di un problema con il razzo usato per portarlo in orbita del veicolo Thor-Delta, il pallone finì per ricadere nell’oceano Atlantico, dove per quanto ne sappiamo giace tutt’ora. Il che avrebbe certamente costituito un contrattempo eppure, nulla più questo…
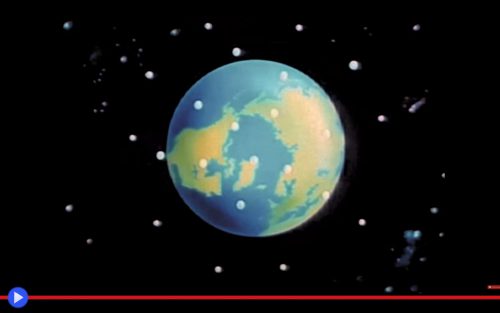
Il primo di questi palloni a raggiungere effettivamente l’orbita fu quindi l’Echo 1A, ufficialmente chiamato soltanto Echo 1 per ovvie ragioni di prestigio, esattamente nella giornata del 12 agosto 1960. L’oggetto essenzialmente indistinguibile dal suo predecessore, con una massa di ben 180 Kg, venne quindi gonfiato mediante l’impiego di uno speciale gas creato a partire dalla sublimazione di una polvere, mescolanza di antraquina ed acido benzoico, capace di espandersi fino ad alcuni chilogrammi di sostanza abbondantemente sufficienti ad espandere la sfera ad un’altitudine minima di 1.029 Km sopra la superficie terrestre. Laddove sulla Terra, durante le prove di gonfiaggio all’interno dell’hangar in condizioni di pressione superficiale, lo stesso obiettivo aveva richiesto ben 18.000 Kg di aria attentamente veicolata al suo interno. Il satelloon, come era stato ribattezzato a beneficio della stampa da un’unione delle due parole satellite e balloon, sarebbe stato quindi impiegato di concerto con una serie di stazioni radio allo stato dell’arte, le più grandi e famose delle quali si trovavano presso il lago prosciugato di Goldstone, nel deserto del Mojave e ad Homdel, New Jersey. Fu allora che alcuni dei piani più interessanti sul loro possibile impiego presero a prendere forma. Tra tutti quello di Arthur Summerfield, l’allora dirigente delle Poste americane, che con grande risonanza mediatica concepì in quel contesto l’idea del sistema Speed Mail, per l’invio di lettere scansionate mediante Fax attraverso una futura rete di satelliti passivi sferoidali, con un ritmo ipotetico di 15 lettere l’ora. Il successo dei primi segnali fatti rimbalzare sulla sfera divenne quindi ben presto una notizia nazionale, rendendo particolarmente celebre l’oggetto iperboreo, che grazie alla sua luminanza inerentemente notevole risultava tra l’altro visibile ad occhio nudo, come una sorta di stella mobile nel firmamento terrestre. L’idea che il pallone, con l’unica strumentazione a bordo di un transponder per seguire i suoi movimenti, sarebbe decaduto dall’orbita e precipitato a terra nel giro di un anno appena si dimostrò ben presto eccessivamente pessimistica, quando al lancio del secondo satelloon Echo 2, nel 1964, esso si trovava ancora in alto nei nostri cieli notturni. Fu nel corso della vita operativa di quest’ultimo, una versione come dicevamo ancor più grande pari a 41 metri di diametro, che nacque l’idea di misurare gli spostamenti relativi di tali oggetti tramite l’impiego di precisi strumenti ottici, agevolando lo studio della forma planetaria noto come geodesia, che avrebbe in seguito condotto alla localizzazione terrestre. E benché nessun tipo di vera e propria localizzazione GPS fosse possibile mediante l’impiego di simili oggetti, ben al di sotto di una vera e propria orbita geostazionaria, essi si sarebbero dimostrati utili in una finalità particolarmente interessante: la triangolazione della posizione di Mosca, possibile bersaglio di missili intercontinentali all’apice della guerra fredda. Un’ideale traguardo perseguito ulteriormente mediante l’impiego del successivo PAGEOS (PAssive Geodetic Earth Orbiting Satellite) lanciato nel 1966, con un diametro di 30 metri e foggia esteriormente indistinguibile dai due esemplari precedenti.

Disgregatosi per l’impatto reiterato di micrometeoriti ed infine precipitati ad ardere nell’atmosfera rispettivamente nel 1968 e 69, i due satelliti Echo avevano ormai aperto la strada ad nuovo, per quanto transitorio capitolo delle comunicazioni globali. Ben presto destinato all’obsolescenza per l’impiego dei più moderni ed affidabili satelliti dotati di sistemi attivi per la trasmissione delle onde radio, ma non prima o almeno non del tutto entro l’anno 1976, in cui venne lanciata l’evoluzione dell’idea identificabile con l’acronimo di LAGEOS, il Laser Geodynamics Satellite. Essenzialmente nient’altro che una sfera di alluminio ricoperto di ottone, del diametro di appena 60 cm pari a due palloni da basket, coperta di 426 specchi in silicio e germanio, perfettamente individuabile da terra mediante l’utilizzo di una serie di semplici strumenti. Costruita in due esemplari, il secondo dei quali inviato in orbita nel 1992, questa tipologia di oggetto si sarebbe quindi dimostrata molto più resistente all’ambiente inospitale dello spazio esterno, essendo entrambe le sfere ancora in posizione al conteggio degli anni attuali. Ed auspicabilmente ancora per moltissimi altri a venire, come esemplificato dalla capsula temporale e diagramma cronologico per gli “umani del remoto futuro” progettato dal grande divulgatore scientifico Carl Sagan al fine di essere incluso su una placca integrata nel LAGEOS-1.
Perché intemperie, venti, grandinate, inondazioni, eruzioni ed altri eventi parimenti devastanti sono esclusivo appannaggio dell’ambiente di superficie. E quando fino all’ultima traccia significativa della nostra civiltà sarà ormai potenzialmente scomparsa, alla maniera vissuta dall’antico regno atlantideo, vestigia come queste potranno offrire l’ultima residua testimonianza della nostra pregressa esistenza. E quello che potevamo riuscire a fare, sulla spinta di un bisogno molto umano e alquanto effimero di superare la concorrenza.



