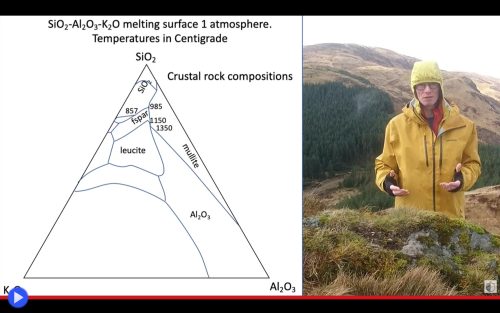Attraverso secoli e millenni inverecondi, sotto l’egida di Dei vendicativi e nel trionfo delle basiche pulsioni animalesche, non è mai cambiato il metodo fondamentale usato dagli umani per imporre le proprie verità nel mondo. Forza d’intenti e convinzioni, quell’identità possente ed immutabile di chi è convinto. Ma soprattutto ed al di là di ogni possibile punto di vista, la forza inarrestabile delle armi. Strumenti antichi come quelli che governano l’istituzione stessa della civiltà, spesso identificati in qualità di metodi per elevarsi e controllare la natura. Primo tra tutti, il fuoco. E i segni bellici del suo utilizzo, l’energica possenza concentrata ove un qualcosa che era stato necessario, ora sognava di essere distrutto. Come cicatrici senza tempo, cumuli di pietre parzialmente annerite si presentano in alcuni luoghi dell’Europa settentrionale. Ma soprattutto in Scozia, con gli esempi più famosi a Dun Mac Sniachan (Argyll), Benderloch (Oban), Craig Phadraig (Inverness). La cui caratteristica fondamentale, a ben vedere, è la collocazione paesaggistica sulla cima di elevate colline, in quanto pratici residui di fortezze utilizzate dai remoti predecessori della collettività presente. Nulla spiega, tuttavia, l’esatta ragione e soprattutto il metodo dell’implicita modalità impiegata in questo tipo di trasformazione edile. Giacché ad un’analisi più approfondita, come praticata per la prima volta nel 1777 dall’archeologo John Williams, queste rovine risalenti all’epoca della Preistoria presentano profonde alterazioni che vanno ben oltre tale cromatismo delle rocce dioritiche soggette al trascorrere di incalcolabili generazioni umane. Con parti fuse al punto di apparire lucide, simili a smalti polverosi, che fluiscono in forme organiche del tutto degne di figure e ambientazioni del fantastico contemporaneo. Il che significa, in termini di tipo più conciso, che sono stati sottoposti ad un processo antropogenico di vitrificazione.
Qualcosa di difficile ed inevitabilmente complesso da implementare, soprattutto sulla scala degli svariati centinaia di metri coinvolti nel caso di talune cinte murarie; considerate, a tal proposito le temperature necessarie alla fusione dei graniti, agevolmente superiori al migliaio di gradi. Non così difficili, nell’Età del Ferro, da raggiungere all’interno di un forno per la ceramica. Ma tutt’altra cosa è farlo sulla scala di elementi architettonici di proporzioni tanto significative. Il che si affrettò ad aprire, già nella tarda epoca dei Lumi, la questione tanto che in un celebre studio sperimentale di Childe e Thorneycrof presentato alla Royal Society nel 1937, si esordisce con la locuzione: “A tal punto la questione dei forti vitrificati ha occupato le sessioni precedenti di questa prestigiosa istituzione, da non portarci a ritenere necessarie ulteriori spiegazioni di cosa siano. Ecco, dunque, ciò che abbiamo scoperto…”
L’approccio dei due ricercatori, rispettivamente un archeologo australiano ed un ingegnere minerario britannico, avrebbe indubbiamente contribuito gettare nuova luce su una delle potenziali casistiche coinvolte nell’alterazione dei manufatti, sebbene in seguito molti avrebbero gettato significativi dubbi sui presupposti. Essi provarono, in effetti, come la tipica costruzione del murus gallicus, ampiamente descritto da Giulio Cesare nelle sue memorie, sottoposto ad un incendio avrebbe potuto idealmente raggiungere le temperature necessarie a fondere le piccole pietre impiegate per costituire la parte centrale del terrapieno. Ciò in funzione degli elementi trasversali contenuti all’interno, in legno, di frassino, pino o quercia, capaci di raggiungere spontaneamente il punto critico già oggetto di menzione. Ancorché rimanga significativo il fatto che tale complicato approccio architettonico, anche nelle comunità continentali di quell’epoca, raramente veniva utilizzato per edificare strutture della dimensione dei forti scozzesi oggetto della disputa. Ed esso avrebbe d’altra parte richiesto il coinvolgimento di quantità di uomini e mezzi fuori scala per la dimensione tipica di una comunità scozzese dell’ottavo, nono secolo a.C. Obiezioni destinate a riportare l’incertezza nell’identificazione del metodo, e conseguentemente la ragione alla base di questa tipologia d’interventi. Poiché la vitrificazione richiedeva, al minimo, svariate ore al fine di essere portata a compimento, appariva improbabile il suo impiego come chiave d’accesso al forte nel corso di un concitato assedio. Soprattutto visto come realizzarla avrebbe richiesto, da parte dell’esercito attaccante, il trasporto di ponderose cataste di tronchi da appoggiare alle alte mura, senza che nessuno intervenisse ad interrompere la complicata operazione. Ciò senza considerare l’ipotetico impiego, comunque non ancora attestato all’epoca fuori dall’area geografica della Grecia, di sostanze incendiarie antesignane al molto successivo fuoco greco. Ancorché, fattore non da poco, va considerato come fondere la pietra non crei in modo automatico alcun tipo di breccia, ma si limiti a privare il materiale della propria resistenza agli urti. Il che avrebbe ancora richiesto l’utilizzo di un ariete, che comunque avrebbe avuto come bersaglio preferibile un qualsiasi tipo di porta. Molto più probabile appare, a tal proposito, la proposta di archeologi contemporanei, che vedono l’impiego delle fiamme come parte di un processo di demolizione successivo alla conquista, in qualche modo rituale o addirittura connotato da elementi religiosi o sovrannaturali. La fusione dei forti nemici avrebbe potuto, a tal proposito, motivare il popolo alla guerra o la resistenza, mostrando come nulla potesse resistere alla furia dei loro condottieri. Ciò avrebbe potuto possedere anche meriti di tipo strategico, con l’eliminazione di postazioni indifendibili in maniera sistematica, così come avrebbero in seguito imparato a fare i Romani durante le loro lunghe campagne di conquista.
Degna di collaterale menzione, benché ancor meno probabile, l’idea che la vitrificazione potesse essere in qualche maniera intenzionale, come alternativa all’utilizzo di cementi o malta non facilmente disponibili ai tempi della Preistoria, in funzione del modo in cui essa provvedeva a saldare assieme le pietre distinte. Il che comunque non prende in considerazione l’utilizzo sempre possibile della costruzione di mura a secco, mediante l’uso di rocce più grandi abilmente incastrate tra loro. Approccio di cui abbiamo ampi esempi in Scozia e il resto dell’Europa databili all’epoca a cui risalgono queste singole anomalie locali.
Potenziali esplosioni atomiche, invasioni aliene o l’intervento di esseri venuti da altre dimensioni, pur essendo stati oggetto del dialogo in tempi fin troppo recenti, non hanno dunque alcun motivo di venire chiamati in causa. Perché ridisegnare l’intero corso possibile della storia umana, quando la tecnologia necessaria a fondere la pietra era da tempo disponibile ai possessori delle misteriose mura vitrificate?
La cui reale comprensione implica, fondamentalmente, la “mera” elaborazione di un pretesto e la ragione pratica d’implementarlo sulla vasta scala richiesta. Missione indiscutibilmente destinata a rimanere impossibile, a meno di trovare nuova documentazione scritta sul tema di una di queste ipotetiche cerimonie, o demolizioni successive al dipanarsi di feroci battaglie. Poiché è possibile simulare i metodi e si possono elaborare teorie infondate sulla ragionevole natura di un costrutto fuori dal contesto. Ma difficilmente appare giustificabile, tentare ostinatamente di inventarselo di sana pianta.