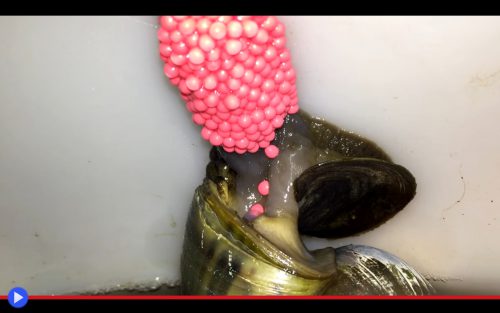È una foto così perfetta, nell’illustrare la natura e la portata del problema, che alcuni hanno suggerito che possa in effetti trattarsi di un allestimento artificiale. Il mammifero marino bianco e nero giace all’apparenza immobile tra le maglie di una rete da pesca. Assomiglia vagamente ad un delfino, benché sia privo del muso allungato delle varietà più famose, la testa non abbia la tipica forma bulbosa (il “melone”) e l’interezza delle proporzioni, così corte e tondeggianti, porti istintivamente a pensare al cucciolo di una qualche specie mai vista prima. Il che, inevitabilmente, ispira un senso d’istintiva grazia ed affabilità. Ma non è questa l’unica ragione: in una descrizione veramente completa della creatura, non si può certo tralasciare la vistosa cerchiatura nera degli occhi, che assomiglierebbe quasi a quella di un panda, se non fosse per la forma geometrica tonda pressoché perfetta. E poi, c’è quella lieve inclinazione della bocca verso l’alto, come se il povero animale stesse, in effetti, sorridendo. Il che non può che indurre in noi uno spontaneo senso d’empatia. Finché non ci si rende conto, in effetti, di essere probabilmente di fronte a un esemplare appena transitato a miglior vita. Purtroppo, il più delle volte, capita così: su Internet non esistono praticamente foto di vaquitas del Golfo della California (Phocoena sinus) che siano ancora vive, per la semplice ragione che al conteggio attuale, secondo studi approfonditi con l’ausilio della scienza statistica, ne restano in circolazione appena 60, esemplare più, esemplare meno. Siamo dunque di fronte, volendo essere del tutto chiari, a uno dei singoli animali a maggior rischio d’estinzione della Terra, condizione ulteriormente esacerbata dal fatto che l’animaletto in questione, come tutte le focene, mal si adatta alla vita in cattività, e proprio per questo non ne esistano coppie fertili all’interno degli acquari o i santuari di conservazione ecologica. Nei fatti, l’intera popolazione di questo relativamente piccolo abitante degli oceani (misura massima della femmina: 140.6 cm, del maschio 134.9 cm) vive allo stato selvatico nell’area di uno dei tratti di mare più pesantemente industriali, e pescosi, dell’intera America Settentrionale. Ancora fino al 2021-22, volendo affidarci alle stime più pessimistiche, prima che i fattori che hanno inciso in queste ultime generazioni sulla sua sopravvivenza, inevitabilmente, mietano l’ultima vittima individuale, relegando la specie una mera pagina commemorativa sui libri di storia della biologia, giusto accanto al delfino di baiji, estintosi nel Fiume Azzurro della Cina appena una decina d’anni fa.
Il che sarebbe, oltre che un peccato, un problema alquanto significativo per l’intero ecosistema marino della Bassa California, la penisola che racchiude, assieme alla costa del Messico, questo tratto di mare dall’insolita e preziosa biodiversità. La vaquita infatti, termine che vuole dire, letteralmente, “mucchetta”, ha un ruolo primario nella depopolazione dei pesci scienidi, dei perciformi e delle trote di mare, che vivono e si riproducono vicino al delta del fiume Colorado. Costituendo inoltre, come molte altre specie marine, anche la preda di un qualcosa di più grande, e nello specifico gli squali, la scomparsa delle focene potrebbe privare questi ultimi di una fonte potenzialmente fondamentale di cibo. Dando l’inizio ad un effetto a catena il cui estremo termine, nei fatti, esula grandemente dalla nostra capacità di previsione. A causa di questo suo specifico ruolo nello schema delle cose, la vaquita vive primariamente nell’area settentrionale del golfo, nota geograficamente come Mare di Cortez, all’interno di lagune non più profonde di 50 metri, e non più lontane dalla costa di 25 Km, possibilmente in presenza di acque torbide per la presenza di alghe, e quindi ricche di sostanze nutritive per assicurare la presenza delle loro prede preferite, che includono anche seppie e crostacei. Ed è proprio questa collocazione tanto specifica in un habitat estremamente definito, a darci un idea chiara della portata e natura del problema: quanto può essere difficile, in effetti, proteggere un’area tanto ridotta dei nostri oceani, dove potrebbe bastare una sorveglianza assidua da parte dei governi americano e messicano, nel rapporto delle popolazioni con il mare, per assicurare la continuativa sopravvivenza delle specie chiave? ESTREMAMENTE difficile, a quanto pare. E andiamo adesso ad elencarne le ragioni…