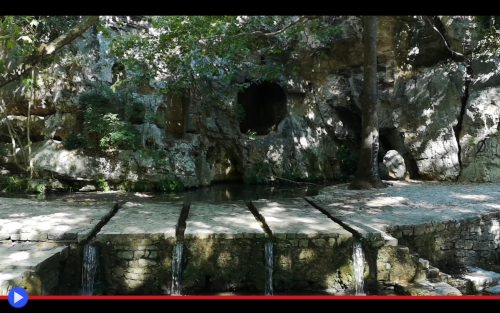Se il mondo terreno è la diretta risultanza di un sistema di regole e cause più o meno remote, complessivamente iscritte sulle pagine del Fato da una serie di divinità del tutto consapevoli e più o meno interessate alle tribolazioni umane, ne deriva che un preciso metodo pensato per interfacciarsi con queste ultime possa fornire indizi funzionali e approcci sistematici, capaci di aiutarci nelle nostre scelte quotidiane verso la realizzazione d’importanti aspirazioni ed obiettivi personali. Ciò fu la sostanziale base operativa in molte culture del Mondo Antico soprattutto occidentale, per l’istituzione di siti mistici ove il confine tra i due τόποι contrapposti dell’umano e il sovrannaturale diventava straordinariamente labile, permettendo a individui forniti del rilevante “dono” di abbandonarsi al flusso dell’ispirazione, in grado d’indicare grazie a profezie o visioni l’effettivo aspetto della Via intrapresa. O almeno, questo era l’approccio previsto dalla convenzione. L’esistenza di sacerdotesse o profeti adibiti a tale compito, come nei celebri oracoli di Delfi, Dodona e Cuma nei Campi Flegrei, rende legittimo il sospetto a posteriori, e possibilmente già nell’epoca tarda, che il messaggio riportato non fosse sempre l’effettiva risultanza di queste premesse, bensì un tentativo scaltro di manipolare menti deboli o eccessivamente rispettose delle tradizioni religiose coéve. Forse proprio in funzione di questo, l’unico dei siti in grado di continuare ad operare almeno fino al secondo secolo d.C, quando venne visitato e descritto dallo storico di epoca romana Plutarco, fu quello dedicato al culto ctonio del misterioso dio Trofonio della Beozia, l’unico capace di comunicare senza intermediario con i propri supplicanti. O almeno quelli tra coloro intenzionati ad affrontare una delle più terribili esperienze collegati a tale prassi, da cui si usciva tanto spesso cambiati nel proprio essere ed in grado ad un diffuso modo di dire, non più capaci di sorridere “alla stessa maniera”.
Ne parlò ancor più estensivamente Pausania il Periegeta (110-180 d.C.) nei suoi diari di viaggio confluiti nella Periegesi della Grecia, con trattazioni lunghe e approfondite dei molti luoghi eccezionali di questo antico paese, inclusa per l’appunto la fiorente cittadina di Livadeia, situata lungo il corso del fiume Ercina. Così chiamato per l’appunto, proprio dall’appellativo della ninfa o naiade con il mandato di proteggerlo, versione sottoposta ad apoteosi della figlia di Trofonio stesso, un celebrato eroe figlio del Sommo Zeus che aveva posto l’una sopra l’altra, assieme al fratello Agamede, le sacre pietre dell’Oracolo di Apollo dove la Pizia riceveva i propri vaticini allucinatori. Soltanto affinché i due ricevessero, come prima profezia divina, il mandato a realizzare con successo qualsivoglia desiderio per sette giorni successivi. Al termine dei quali, la loro vita s’interruppe all’improvviso e senza alcune possibilità di appello, da cui il detto “Chi è amato dagli Dei non vive mai eccessivamente a lungo.” Ma i miti greci come è noto sono molteplici e contradittori, per cui sussiste un’interpretazione alternativa di quel personaggio, alla base del suo approccio insolito, così notoriamente utile a manifestarsi e prevedere gli eventi futuri…
personaggi
Così attraverso i secoli tra l’isola di Ceylon e Tamil Nadu, tutti i ponti si fermavano a Rameswaram
Alla testa di un esercito formato dai suoi più fedeli alleati e sottoposti, l’eroico condottiero Rama, materiale personificazione di una divinità, si trovò innanzi ad un oceano vasto e sterminato. Era soltanto oltre il confine ultimo dell’India, a molte miglia di distanza, che sapeva sorgere l’inespugnabile fortezza di Lanka, ultima roccaforte del Re dei Demoni, Ravana. Antico avversario di tutte le genti del mondo, ma anche e soprattutto il suo nemico personale, avendogli sottratto l’amata moglie Sita, dopo averla ingannata assumendo le sembianze di un asceta affamato. Mentre già tendeva il proprio arco sovrannaturale per dividere le acque di quei mari, il dio Varuna giunse dagli abissi cavalcando il proprio coccodrillo, al fine di proporgli una soluzione più efficace e molto meno distruttiva: “Chiedi ai tuoi uomini di accumulare pietre e farle rotolare oltre la costa. Scoprirai che grazie alla mia intercessione, esse non affonderanno.” Giungendo in questo modo al rapido coronamento del proprio progetto, il fiero condottiero andò in battaglia. Il resto, come si dice, è leggenda. Ma per chiunque abbia un’esperienza pratica dell’area geografica dove si svolse la vicenda, c’è una diretta corrispondenza tra i fatti fin qui narrati e una diretta concatenazione di scogli, secche ed altri ostacoli alla navigazione situata esattamente tra la punta meridionale del subcontinente indiano e la grande isola dello Sri Lanka, situata si ritiene in effettiva prossimità (pur non essendo formalmente la stessa cosa) della non più esistente fortezza marina dei demoni/rakshasa. L’anche detto “ponte” o setu di Adamo, poiché in base alle credenze islamiche, la sua funzione sarebbe stata piuttosto quella di permettere al primo degli uomini di lasciare l’isola del Paradiso terrestre, per insediarsi successivamente proprio qui, sulla più vasta e variegata penisola del pianeta. Quella nazione paradossalmente andata incontro ad un’identità indivisa proprio successivamente ai lunghi anni di amministrazione coloniale, quando il Raj britannico non lasciò nulla d’intentato nel propagare i punti d’interscambio e incrementare conseguentemente le possibili fonti di guadagno commerciale. Il che andò incontro, per quanto concerne tale spazio verso la fertile e gremita landa nota un tempo come Ceylon, all’ostacolo logistico del fin troppo tangibile Rama setu, necessitando di una piattaforma portuale situata in maniera maggiormente coerente. La cui collocazione ideale, entro la fine del XIX secolo, era stata lungamente individuata nell’isola interposta di Pamban. Proprio lì dove sorgeva l’insediamento da decine di migliaia di persone, costruito attorno al sacro tempio di Ramanathaswamy, dedicato all’impresa di Rama e tutto quello che sarebbe venuto dopo. Un luogo al termine d’innumerevoli pellegrinaggi, che anche soltanto in funzione di ciò avrebbe potuto beneficiare di un metodo permanente per collegarsi alla terra ferma. Con il coinvolgimento d’ingegneri provenienti dalla Germania e l’Inghilterra, fu dunque realizzato tra il 1911 e il 1914 il progetto di un moderno ponte ferroviario, la cui lunghezza tutt’altro che trascurabile raggiunse i 2,065 Km, ed la cui campata centrale dell’ampiezza di 65 metri fosse dotata di un sistema basculante modello Scherzer, che avrebbe permesso agli operatori di sollevare in due parti la carreggiata per permettere alle imbarcazioni di passare oltre. Non tramite l’impiego dell’ancora inaffidabile elettricità, bensì l’approccio totalmente manuale di una manovella, collegata ad ingranaggi e un contrappeso simile a quello di un cavallo a dondolo sovradimensionato. Fu perciò l’inizio di una nuova epoca di prosperità, sebbene le difficoltà ambientali e varie circostanze fossero destinate a porre non pochi ostacoli al pendolarismo ferroviario del secolo successivo…
Il mistero lungo secoli del tè azzurro in grado di tonificare la funzionalità renale
Nell’anno del Signore 1646, il rinomato studioso gesuita e polimata Athanasius Kircher venne in possesso di un oggetto ricevuto in dono dai propri colleghi missionari di ritorno dal Messico. Come uno degli oggetti mitologici più rinomati del Cristianesimo, esso si presentava con l’aspetto di un calice, egualmente dotato di presunti effetti taumaturgici capaci di sanare le afflizioni umane. Dopo aver condotto in Vaticano una serie di esperimenti molto approfonditi in base alle conoscenze del tempo, l’ecclesiastico decise di acquisire credito inviando il singolare manufatto alla corte di Ferdinando III, Sacro Romano Imperatore. Ma non prima di scrivere: “Il legno dell’albero in questione, quando lavorato nella forma di una coppa, tinge l’acqua di un colore simile a quello del fiore della viperina azzurra. Se poi l’acqua viene riversata in un bicchiere trasparente e posta controluce, essa apparirà di nuovo limpida e chiara. Ma quando spostata verso un luogo ombroso, diventerà progressivamente gialla, poi rossa e infine blu scuro.” L’uomo della Santa Sede era stato in effetti il primo a descrivere, in maniera tanto approfondita, la fluorescenza. Ma non l’effetto visuale del cosiddetto Lignum nephriticum, sostanza in apparenza tratta dal tronco di una pianta già individuabile all’interno dei diari del francescano Bernardino de Sahagún nel 1569, che aveva incontrato nei suoi viaggi verso il Nuovo Mondo le popolazioni autoctone che solevano chiamarlo in lingua Nahuatl, coatl tenendone gli estratti in alta considerazione per la rinomata capacità di curare ogni tipo di afflizione del tratto urinario. Avendo portato indirettamente alla nascita negli anni successivi di una fervida ricerca da parte dei medici e guaritori europei degli ambìti pezzetti di legno rossastro, tagliato e sminuzzato, come l’ennesimo prodotto miracoloso proveniente dalla terra straordinaria all’altro lato dell’Oceano Atlantico. Dando luogo presto l’idea tipica degli albori del mondo moderno, secondo cui l’osservazione di un fenomeno ripetibile in condizioni sperimentali dovesse necessariamente presentare pratiche corrispondenze negli effetti di un bene o una sostanza, stabilendo in via del tutto empirica una connessione tra la capacità di produrre un colore tanto innaturale e insolito come l’azzurro, con le presunte doti quasi magiche del fluido taumaturgico risultante. Il che avrebbe reso in apparenza superflua ogni verifica di provenienza delle piante vendute come kidneywood o “legno dei reni”, purché fossero capaci di cambiare il colore dell’infuso risultante, con ogni variazione d’intensità attribuita, convenzionalmente, alla qualità dello specifico campione. Un fraintendimento che traeva origine a ogni modo, e imprescindibilmente, dal fondamentale errore iniziale. Giacché il mistico Graal descritto da Kircher, guarda caso simile ad un altro oggetto venuto in possesso in epoca coéva del botanico svizzero Johann Bauhin, non proveniva affatto dal remoto continente occidentale, bensì una terra posta direttamente all’opposto nella geografia del nostro vasto e azzurro pianeta…
L’orchestra strutturale di maioliche che sfidò in Serbia le rigide architetture del Kaiserlich
C’è una vista che accoglie chi esce alla stazione ferroviaria centrale di Subotica, città serba da poco più di 88.000 abitanti situata non troppo lontano dal confine con l’Ungheria. La facciata di un palazzo simile all’illustrazione di una fiaba, che per il suo esplicito eclettismo, originalità e stile riesce a offrire l’antefatto per l’atmosfera di un quartiere unico nell’Est Europa e nel mondo. Un polo guarda caso di concentrazione, per risvolti casuali della storia e scelte individuali pregresse, di menti eccelse nella storia dell’architettura, ma ancor prima di questo avanguardisti e impavidi ribelli, intenti a coltivare il fervido sistema di un diverso canone esteriore. Ambiziosamente moderno e tradizionalista al tempo stesso, nella misura in cui ci si sforzava di riprendere i motivi endemici della cultura nazionale assieme a ciò che in ogni giorno riesce a connotare ed arricchire la nostra esistenza: la natura stessa. Tramite l’applicazione della cosiddetta Gesamtkunstwerke o “l’opera d’arte complessiva”, un concetto creato in Germania dallo scrittore e teologo K. F. E. Trahndorff e reso popolare da Richard Wagner, quattro decadi prima di assurgere al fondamentale punto di partenza per la corrente parigina dell’Art Nouveau, con manifestazioni destinate a persistere nella pittura, nell’illustrazione, nella moda, nell’arredamento e soprattutto l’architettura. Giacché non è possibile, e neppure immaginabile, voltarsi o rimanere indifferenti innanzi ad edifici come la residenza di Raichle, palazzo multipiano costruito nel 1903 all’interno di un contesto in divenire, che l’avrebbe conseguentemente cementato (e decorato) a beneficio imprescindibile dei suoi contemporanei e le generazioni a venire. Considerato a buon ragione come uno dei più notevoli esempi esistenti del reinterpretato szecessziós stílus o approccio controcorrente, rispetto alla visione accademica degli spazi abitativi entro il territorio del confinante Impero austro-ungarico, che all’epoca aveva già raggiunto il proprio apice grazie all’opera di figure come Ödön Lechner e Dezső Jakab. Sebbene questi non avrebbero trovato l’occasione né sentito il bisogno, contrariamente a Ferenc Raichle, di trasformarsi essi stessi in investitori, erigendo un capolavoro in grado di servire da evidente manifesto autogestito della propria visione artistica del tutto fuori dall’ordinario. Ecco dunque un luogo, letteralmente e in senso pratico, “del cuore” così come esemplificato dal motivo cardiaco ricorrente, dalla forma del cancello in ferro battuto a quella dei parapetti delle balconate e dei bovindi sopraelevati, senza tralasciare lo stesso ingresso incassato da cui s’irradiano, richiamando il frontespizio di tomo fantastico, figure geometriche di gigli in verità composti dallo stesso organo simbolico delle aspirazioni e i sentimenti del corpo umano. Come punto di partenza che va oltre la semplice ricerca visuale, entrando a pieno titolo nel regno spesso metaforico della filosofia…