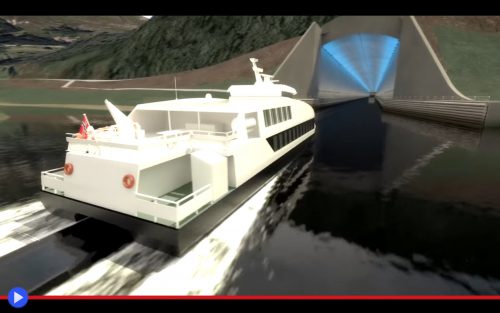Annientare le manifestazioni del diavolo sulla Terra. Questo era, tra gli altri, l’obiettivo percepito di un buon governo, finché la laicità della legge e dello stato, come concetto fondativo della democrazia stessa, non iniziò a farsi strada tra le norme operative dei legislatori e dei magistrati. Di sicuro, quindi, si tratta di un pensiero atipico al giorno d’oggi, ma che nel 1751 doveva essere al centro dei pensieri del Parlamento della Gran Bretagna, quando ci si riunì per emettere la complicata serie di norme e regolamenti che sarebbe passata alla storia come il Gin Act. Mirate a ridurre la diffusione, per quanto possibile, de “La principale causa di tutti i vizi e la dissolutezza messi in pratica da un certo tipo di persone provenienti da un certo tipo di classe inferiore.” Ah, se soltanto potessero vederci adesso! A prendere nota, con il massimo interesse, delle ultime trovate di un’industria che è diventata solamente un po’ desueta, e proprio per questo il simbolo di un mondo raffinato ed elegante, che si trova collegato al concetto di godersi la vita. Tanto che, fra tutti i luoghi oggetto di una visita educativa, possiamo essere orgogliosi d’includere anche una distilleria. E di che tipo… Tutto risale, per essere precisi, al recente 2011, quando la compagnia Bombay Sapphire, di proprietà del gruppo inglese Bacardi, acquistò i locali per l’apertura di un nuovo stabilimento di produzione, che offrisse anche l’attrazione di un completo centro visitatori. Con la scelta che ricadde, dopo un’attento lavoro di ricerca, su un’antico mulino dal nome di Laverstoke, quindi cartiera per la produzione di banconote durante l’epoca Vittoriana, sito tra le municipalità di Whitchurch ed Overton, nella contea di Hampshire. Un vasto complesso ormai largamente derelitto, composto in parti uguali di antichi edifici rientranti nella categoria protetta ed aggiunte più moderne, comparabilmente prive di fascino e di valore, il tutto attraversato dalle fresche acque del fiume Test. Al che Will Brix, l’amministratore della proprietà, ebbe l’idea innovativa e dirompente di unire l’utile al dilettevole, per così dire, e rendere lo stesso impianto di produzione, con gli alambicchi, le tubazioni e tutto il resto, l’oggetto principe dell’attrazione turistica connessa all’impianto. E perché no, dopotutto…Cosa c’è da nascondere! Ma l’offerta di uno sguardo da vicino alle forme scultoree dei macchinari in rame, ai vasti capannoni e l’assaggio garantito di almeno una versione della popolare bevanda, a torto o a ragione, non furono giudicati abbastanza. Fu quindi deciso, come ulteriore accrescimento del fascino contestuale, di assumere per il progetto di restauro niente meno che lo studio dell’architetto Thomas Heatherwick, già famoso su scala internazionale per il padiglione inglese alla Fiera Mondiale di Hong Kong e che lo sarebbe stato di nuovo ben presto, per la grande torcia olimpica di Londra nel 2012. Da una serie di meeting che possiamo immaginarci essere stati senz’altro ricchi di spunti interessanti, lo specialista e il suo team finirono quindi per avere una geniale intuizione. E se la fabbrica mettesse in mostra, presso i suoi stessi locali, le famose 10 erbe (i cosiddetti botanicals) dalla cui infusione tramite processo di distillazione derivava il sapore caratteristico di questa ricetta risalente al 1761? E se per farlo si fossero usate non una, bensì due serre? E se queste serre, come loro prerogativa del tutto unica al mondo, avessero usato per la creazione del microclima interno il calore stesso derivante dal particolare processo di produzione del gin Bombay Sapphire?
La riposta a queste ed altre domande, nonché a un’esigenza che non sapevamo di avere, fu dunque l’evoluzione stessa del concetto di un’ambiente artificiale in cui far crescere le piante, creato attraverso l’assemblamento di esattamente 793 pannelli di vetro, in un’ìntelaiatura d’acciaio dalla forma organica e quasi naturalistica, che sembra scaturire per volontà propria da alcune delle finestre della distilleria. Per andare a formare due padiglioni, l’uno più grande, con ambientazione mediterranea, contenente mandorli, limoni, angelica, radice di iris, seme di coriandolo e ovviamente, le bacche di ginepro da cui viene il nome stesso del “gin”. Mentre l’altro, di dimensioni minori e un grado d’umidità più intenso, con arbusti di cassia, grani del paradiso, liquirizia e cubeb. Tutti assolutamente ed effettivamente necessari, perché inseriti nella cesta stessa posizionata sopra ciascun grande alambicco, secondo la metodologia del processo chiamato racking, messo in pratica per la prima volta dal leggendario fondatore aziendale Thomas Dakin. Consistente nel far evaporare l’alcol, attraverso l’apposito condotto, fino ad assumere in se il gusto di tali e tanti tesori del gusto, per poi liquefarsi nuovamente all’altro capo del meccanismo. Mentre il suo calore in eccesso, secondo il preciso piano di Heatherwick e Brix, viene deviato verso le serre collaterali allo scopo, in un circolo virtuoso di assoluta eco-sostenibilità… O almeno è questo, ciò che ci piacerebbe pensare.