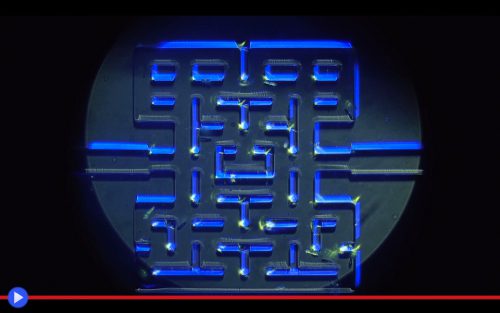Ehi, tu! Osserva il contenuto di questa immagine. La vedi quella minuscola cosa rossa, accanto alla massa giganteggiante dell’Australia? Ecco, stai guardando la Gran Bretagna. Si, con Inghilterra, Scozia e Galles. L’isola più grande con tutte le altre, e soltanto un pezzettino dell’Irlanda settentrionale, che Brexit a parte, continua a incoronare qualsiasi immagine dell’Europa. La quale nella visualizzazione più spesso usata delle nazioni, sembrerebbe poter facilmente rivaleggiare con l’estensione longitudinale di alcune parti del paese dei canguri. Si, come no. La realtà, signora mia, la stai vedendo solamente adesso… Forse addirittura per la prima volta: uno scricciolo, un pacchetto di fiammiferi, un ciottolo sperduto nel deserto. Questo dovrebbe sembrarti, persino l’isola più vasta d’Europa, al confronto di quello che pur sempre resta uno dei cinque continenti che compongono le complessive terre emerse del Pianeta. Ed allora perché, normalmente, non sembra affatto così? La colpa, che tale è diventata solamente col trascorrere dei secoli, va attribuita ad una singola persona, vissuta tra il 1512 e il 1594 nella regione delle Fiandre, sita presso il Belgio settentrionale: Gerhard Kremer, passato alla storia con la versione liberamente latinizzata del suo nome, Gerardus Mercator. Matematico, astronomo, cartografo. Geniale manipolatore della geometrica realtà effettiva. Che potrebbe aver modificato in modo indiretto, grazie alla creazione di un sistema fin troppo diffuso di preconcetti (piccolo=meno importante?) La storia stessa dell’intera Terra.
Passiamo quindi alla spiegazione del problema di massima. Che potrebbe sembrarvi, a seconda dei casi, scontata ed automatica, oppure un qualcosa di assolutamente sorprendente ed inaspettato. Il che è del resto molto logico, visto come si tratti di una tematica che viene comunemente affrontata, o almeno DOVREBBE esserlo, nel corso del quinquennio che compone la scuola, per l’appunto, elementare. Cosa che tuttavia risulta spesso problematica, per tutta una serie di ragioni. In genere, la spiegazione va così: “Bambini, sappiate questo. La Terra non è piatta, ma ha la forma di un ellisse irregolare, che in geometria viene chiamato il geoide. La mappa che vedete appesa sopra la mia cattedra, invece, non è altro che un’immagine stampata su di un foglio di carta. Questo significa che per rappresentare una cosa tridimensionale in due dimensioni, essa deve scendere a compromessi con la vera forma e dimensione dei paesi. Ricordate, quindi, che non tutto quello che vedete è verità.” Un bravo maestro, a questo punto, potrebbe far seguire a tutto questo degli esempi: “La Russia in realtà non è tanto più larga degli Stati Uniti” Oppure: “La Groenlandia non raggiunge l’estensione verticale dell’Argentina” Ma simili affermazioni del tutto contro-intuitive rispetto all’evidenza dell’illustrazione, penso sia facile capirlo, in mancanza di un’efficace dimostrazione pratica rimangono del tutto indifferenti. Così questo è un dato che una volta assunto in via teorica, scivola via ben presto, per poi tornare nella mente degli adulti solamente nel caso di chi lavora con le mappe quotidianamente. Il fatto è c’è un solo modo, a questo mondo, per dimostrare in maniera evidente la falsità del senso comune in materia: un’animazione, possibilmente interattiva, visionabile attraverso lo schermo di un computer. Un qualcosa come il sito The True Size.com, presso cui il visitatore può scrivere il nome di un qualsiasi paese al mondo, quindi iniziare a spostarlo in giro per il globo, vedendolo deformarsi in proporzione agli altri che costellano la mappa. Scoprendo, senza alcun ombra di dubbio, l’incredibile realtà. Che tutto quello che si trova al di sopra della linea ideale dell’equatore, ovvero la circonferenza massima della Terra perpendicolare all’asse di rotazione, ci appare innaturalmente più grande. E ciò che è posizionato al di sotto di essa, invece, rimpicciolito di parecchie volte. La principale vittima dell’intera faccenda, assai probabilmente è l’Africa. Che nell’opinione comune, non dovrebbe essere molto più estesa dell’Europa Occidentale. E invece…Potrebbe contenerla tutta intera…NEL SOLO DESERTO DEL SAHARA. E allora perché? Per quale assurda ragione, la più erronea visualizzazione del globo terrestre viene comunemente insegnata nelle scuole, e tutti noi cresciamo abituati a considerare il mondo con una prospettiva notevolmente falsata? Continuate a leggerlo per scoprirlo. Ma il punto principale a priori è che nessuna proiezione bidimensionale di uno sferoide, per sua imprescindibile natura, potrà mai mostrare la realtà. Ed è per questo che nelle aule, dovrebbe esserci sempre almeno un mappamondo. O ancora meglio, un PC.