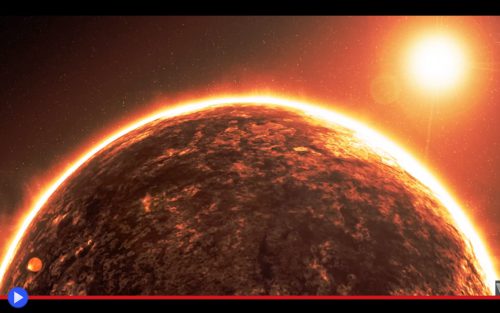La figura in giacca e cravatta a lato della pista di decollo principale dell’aeroporto di Van Nuys si voltò verso il suo nutrito entourage di fisici, ingegneri, uomini d’affari e segretari. Nei suoi occhi risplendeva una luce che non si era vista da ormai da svariati anni : “Azcoltatemi, coleghi! Qvesto è il più importante mezzo che abbiamo per portare noztri piloti su Lùna.” Dietro di lui, svettante come un bizzarro e indecente animale, il più strano aereo che molti di loro avessero mai visto: le ali relativamente piccole, con quattro propulsori ad elica dall’aspetto già piuttosto desueto, in quel 1962 durante il quale persino in campo civile si preferiva impiegare i jet. Ma niente sembrava poter smorzare l’entusiasmo di Wernher Von Braun, il direttore del Marshall Space Center dell’Alabama e quindi, per estensione, una delle figure più importanti in quella particolare fase del programma spaziale americano. Personaggio controverso, non soltanto per la sua nazionalità tedesca ed il ruolo nell’invenzione della bomba V2: il progettista dell’unica arma che fosse riuscita a bombardare Londra, prima di essere espatriato negli Stati Uniti, era stato anche un nazista ed un membro delle SS (benché non per scelta) ed informazioni a quel tempo classificate lo ponevano come perfettamente al corrente delle atrocità commesse nel campo di concentramento di Mittelbau-Dora, da cui lui stesso prelevava i lavoratori da mettere all’opera nella sua fabbrica sotterranea di Mittelwerk. Il suo entusiasmo quasi infantile di quel giorno in cui tutto era stato perdonato, tuttavia, sembrava derivare da una parte completamente diversa di lui, l’infantile passione che gli aveva permesso di diventare un amico personale di Walt Disney, e realizzare assieme al grande intrattenitore una serie di documentari sullo sforzo statunitense per primeggiare lassù, nel cosmo conteso col grande nemico russo. La forma bombata dell’impossibile fusoliera d’aereo si stagliò nettamente, per qualche secondo, tra il cielo e la sua testa canuta, sembrando l’aureola della sua assoluta innocenza. Quando d’un tratto, il velivolo raggiunse la posizione designata ed una piccola figura umana iniziò a scendere dalla scaletta mobile già attentamente posta in posizione.
Il pilota, nonché progettista del Pregnant Guppy (Pesciolina Incinta) era John Michael “Jack” Conroy, un agile quarantenne dalla carriera pregressa ad Hollywood, rimasto celebre nei tardi anni ’30 per la sua partecipazione alla serie di film dei cosiddetti Little Tough Guys, un gruppo d’attori “affascinanti e un po’ maledetti” protagonisti del cinema d’intrattenimento di allora. Che successivamente al suo arruolamento durante la seconda guerra mondiale, aveva assunto il ruolo di pilota di una fortezza volante B-17, il che l’aveva posto, nei fatti, a capo di una squadra di nove membri dell’equipaggio. Finché nel 1942, durante una missione, non dovette paracadutarsi in situazione disperata sopra i campi nei pressi della città tedesca di Zelt, venendo preso prigioniero con un braccio e una spalla fratturati. Il che, lungi dal porre fine alla sua carriera, avrebbe piuttosto rafforzato una profonda passione per l’aeronautica, portandolo successivamente alla sua liberazione nel 1945 ad arruolarsi di nuovo nell’USAF, come pilota sperimentatore ed istruttore delle unità di riserva. Nel 1955, quindi, la singolare figura aveva completato il Progetto Boomerang, pilotando un caccia a reazione Sabre da questo stesso aeroporto di Van Nuys fino a New York e ritorno, nel corso di una sola giornata di volo. Un’operazione che stabilì numerosi nuovi record mondiali. Ma adesso, quasi 10 anni dopo, la commissione della NASA era lì per valutare un suo diverso presunto merito o stravagante follia: l’idea che fosse possibile trasportare i componenti dei loro razzi per via aerea, mediante l’impiego del più brutto e sproporzionato mezzo volante nell’intera storia dell’aviazione. L’ex eroe di guerra aveva rischiato molto per giungere a questo: trasformatasi in imprenditore, nel 1960 aveva fondato la compagnia Aero Spacelines, spendendo tutti i risparmi ed ipotecando la sua stessa casa. Un gesto piuttosto azzardato, quando si considera che il suo unico possibile cliente era il governo. E se quest’ultimo avesse rifiutato…
Il nutrito team d’intervento e spegnimento incendi riservato spontaneamente dalla direzione dell’aeroporto, alla semplice vista di una simile mostruosità che tentava di decollare, ricevette l’ordine di tornare a riposo, mentre Conroy, seguìto dal suo giovane copilota Clay Lacy, si avvicinava con lunghe falcate al compunto scienziato tedesco, enfatico promotore del destino intra-solare, e persino marziano, della futura razza umana. Senza che una singola parola fosse pronunciata, i due si strinsero la mano. Il nutrito pubblico, a quel punto, iniziò ad applaudire.
spazio
Turisti scovano le astronavi sovietiche perdute
Ci vuole coraggio. Occorre fegato, per mettersi alla guida di un SUV al fine di inoltrarsi parecchie centinaia di Km nelle steppe desertiche del Kazakhistan, verso il brullo sito in bilico tra il fiume Syr Daya e il grande lago in via di prosciugamento del mare di Aral. Per eludere nella notte le pattuglie e sconfinare in una delle più vaste zone militarizzate al mondo parcheggiando, infine, a ridosso delle trappole trinciapneumatici, proseguendo a piedi nella notte dell’Asia centrale soltanto per raggiungere un vastissimo, cubico edificio. E tentando di non far rumore, strisciare fino a un’apertura nelle pareti rovinate, giù per una scala dismessa, finché la propria torcia non illumina di lato lo spropositato oggetto di cui si era alla ricerca. Un grosso aereo, lungo 36 metri e pesante a vuoto 42 tonnellate, dalla forma tutt’altro che aerodinamica almeno per quanto sappiamo del volo convenzionale. Questo perché è stato concepito, guarda caso, per qualcosa di totalmente diverso: raggiungere l’orbita terrestre ed iniziare a percorrerla, una volta ogni 40 minuti circa, alla velocità media di circa 28.000 Km/h. In un luogo in cui l’aria non esiste e quindi, ovviamente, neppure la resistenza dinamica dovuta alla sua densità. L’avete visto? Vi ricorda nulla? Se fossimo a Cape Canaveral, non esitereste neanche un secondo nel chiamarlo per nome: “È lo Space Shuttle, non lo dimenticheremo mai…” Ma qui siamo nell’ex Unione Sovietica, e questa cosa ormai ricoperta di ruggine si chiama Buran (tempesta di neve). Loro sono, invece, gli spedizionisti avventurieri del canale Exploring the Unbeaten Path, praticanti olandesi di quell’attività largamente abusiva che prende il nome di Urbex, e spesso consiste nell’insinuarsi all’interno della proprietà privata per prendere atto di un qualcosa di straordinario. Ma personalmente ritengo che mai, nella storia di quest’ambito, si sia giunti ad una simile faccia tosta, e la capacità di rischiare la propria libertà futura con una simile leggerezza. Il gruppo dei tre turisti sembra imitare in effetti, in diversi momenti, le tecniche delle spie dell’epoca della guerra fredda, mentre si nascondono nei recessi del torreggiante hangar, ascoltando suoni lontani e i movimenti delle guardie dell’installazione. Che pur essendo attualmente abbandonata, fa pur sempre parte del cosmodromo di Baikonur, ancora attivamente impiegato perché è l’unico luogo, dotato di rampa di lancio, con latitudine sufficientemente elevata per inviare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). E c’è poi anche il piccolo dettaglio che ad oggi, successivamente al ritiro degli Shuttle americani nel 2011, le navicelle Soyuz custodite nei dintorni di questo luogo sono l’unico veicolo esistente in grado di trasportare esseri umani nell’orbita del pianeta terra. A tal punto, è stato ridotto il budget del leggendario programma spaziale statunitense! Ma se Atene piange, come si dice, Sparta non ride. O per meglio dire, parti di Sparta cadono in rovina per il disuso e l’assenza di manutenzione. Parti costate, a loro tempo, 20 miliardi di rubli (oltre 71 miliardi di dollari) giungendo a contribuire in modo significativo al collasso sociale ed economico dell’Unione Sovietica, avvenuto nel 1991. E dire che all’epoca, erano sembrate COSÌ necessarie…
La comitiva è piuttosto bene assortita: c’è quello prudente, che accetta di buon grado di fare il palo nei momenti più delicati dell’esplorazione, verificando l’eventuale arrivo dei soldati richiamati dal rumore degli ospiti inattesi. C’è il tecnico audio-video, dotato di telecamere e drone d’ordinanza, fermamente intenzionato a documentare ogni minuto di questa irripetibile esperienza. Mentre il terzo uomo, scorpioni tatuati sul petto, si capisce subito essere lo scavezzacollo di ogni situazione, l’arrampicatore di strutture dismesse e remoti pertugi trovati di volta in volta ai margini delle circostanze scoperte. Se questo fosse un cartone animato, mancherebbe soltanto la figura comica del grosso e codardo Scooby Doo. Ma stiamo assistendo ad una situazione, ed un pericolo, assolutamente reale, nel preciso momento in cui i tre raggiungono una stanza senza finestre al primo piano dell’hangar e decidono di passare lì la notte, in attesa di un’alba che, come nel romanzo Rama di Arthur C. Clarke (l’autore di Odissea nello Spazio) illumini all’improvviso l’incredibile aspetto del luogo in cui sono giunti, dopo un lungo e pericoloso viaggio nell’infinito. Proprio mentre dietro la prima astronave, incredibilmente, si profila la sagoma in controluce di qualcosa di straordinario: una seconda, esteriormente del tutto identica a lei…
Il gemello segreto che insegue il Sole
Tutto appariva normale, nel braccio periferico del disco della galassia. Ma se lo si guarda da abbastanza lontano, è praticamente sempre così… Quale enorme supernova, che incomparabile disastro, potrebbe risultare abbastanza forte da scuotere in un dato momento l’agglomerato di un milione di stelle? Ogni cosa è importante, in senso cosmico eppure da un certo punto di vista, proprio per questo, quasi niente lo è davvero. Una simile situazione cambia radicalmente soltanto quando un evento si analizza nello specifico, dal particolare verso l’assoluto, immaginando il punto di vista di chi deve vivere (o non-vivere) con le conseguenze di simili cause spropositate. Eppure, come nel caso delle antipatie e differenze tra antiche divinità, che condussero a guerre apocalittiche nell’era delle antiche mitologie, nessuno poteva davvero profetizzarlo. Quando d’un tratto, trascorsi i canonici 26 milioni di anni, ritornò lui. L’astro cupo delle profondità galattiche, una silenziosa nana grigia dalle emissioni praticamente impercettibili, passando attraverso l’agglomerato della nube di Oort. Colui o colei che da sempre aveva condotto un’esistenza del tutto solitaria, senza influenzare o essere influenzato da chicchessia. Tranne che in quei singoli e rari, ma regolari casi, in cui oltrepassando il velo glaciale, era sbucata nell’oscurità oltre l’ultimo dei pianeti. Trascinandosi dietro una certa quantità di meteore e comete. Stiamo parlando, sia chiaro, di un qualcosa di largamente ipotetico. Una risposta, piuttosto che la domanda, relativa al perché, effettivamente, possa essersi verificata a più riprese l’estinzione di un parte significativa della vita terrestre. Che fa da corollario alla celebre teoria del grande impatto, andando ad analizzarne la remota e poco luminosa ragione: la vendetta di un fratello. Il ritorno di un dio offeso. Colui che nascendo assieme alla nostra stella, aveva avuto la peggio, crescendo debole e malaticcio.
Il come e perché ciò potesse essersi verificato, fin dall’elaborazione di questa sfrenata ipotesi verso la metà degli anni ’80 e la denominazione dell’oggetto col nome piuttosto suggestivo di Nemesis, sono rimasti largamente ignoti alla scienza. Finché lo scorso 28 aprile non è stato pubblicato, sul server online dell’università di Cornell, un nuovo studio realizzato da Steven Stahler, astronomo di Berkeley, e la sua collega Sarah Sadavoy, mirato a presentare un’analisi dell’indagine astronomica di tutte le protostelle della nube molecolare di Perseus, sita a circa 230 parsec dal nostro sistema solare, un’operazione denominata VANDAM (VLA nascent disk and multiplicity survey). La precisa catalogazione, sostanzialmente, di una vera e propria forgia galattica all’interno della quale si verificano la serie di reazioni e coincidenze alla base della nascita di un corpo astrale del tutto nuovo. Il procedimento dell’elaborazione di una statistica matematica, si sa, è la strana prassi per cui il frequente verificarsi di un qualcosa lo rende più probabile in futuro. Oppure, in casi ancora più privi di una logica generativa, si presume succedere l’esatto contrario. Fatto sta che all’ennesimo spalancarsi di una simile finestra sull’infinito, in molti casi la sola che abbiamo, è apparso evidente come la maggior parte delle stelle neonate di classe spettrale G2 di Perseus, ovvero le più simili alla nostra, apparissero come parte di un sistema binario distante. Il che voleva dire, sostanzialmente, che esse ruotavano l’una attorno all’altra, a una distanza di circa 500 unità astronomiche, che poi sarebbero 17 più della distanza che c’è tra il Sole e il suo ultimo pianeta, Nettuno. Questo perché, come ampiamente dimostrato dai radiotelescopi del New Mexico usati nel corso del sondaggio, per ciascuna formazione stellare era presente una concentrazione molecolare nota come “ammasso denso” simile a un uovo con due tuorli distinti. Talvolta più distanti, e quindi propensi a separarsi per l’effetto della forza centrifuga rotativa, e qualche altra invece estremamente vicini, inevitabilmente destinati a formare sistemi multipli come quello della vicina Alpha Centauri. Ma il caso del Sole e di Nemesis, per inferenza, dovrebbe essere ancora diverso, ovvero quello di una delle due parti che assorbe una simile quantità di materiale da subordinare la sua controparte, limitando le sue dimensioni sufficientemente da farla restare intrappolata nel suo campo gravitazionale. Con le succitate conseguenze che purtroppo, noi già ben conosciamo. È una strana correlazione di fattori, che ci permette di comprendere qualcosa del nostro più prossimo vicinato attraverso l’osservazione di una realtà sita ad oltre 700 anni luce di distanza. Il che significa, incidentalmente, che stiamo osservando il passato. Ma questo, come si dice, è tutto un’altro paio di maniche…
Lo scopo di un aereo con la doppia fusoliera
Lanciando il grido acuto che costituisce il suo verso, uno dei falchi più grandi della terra voltò l’affusolato becco verso l’ora del tramonto. Mentre alla sua destra, totalmente impassibile, l’altro uccello faceva lo stesso. Per 3.704 Km (2302 miglia, 2.000 miglia nautiche) erano volati in formazione serrata, le ali interne quasi a sovrapporsi, quelle esterne tese verso l’infinito. Ed ora che avevano raggiunto il punto prefissato, una volta completata la virata e puntando dritti verso l’orizzonte, aprirono i rispettivi artigli, e rilasciarono il cilindro di metallo sopra il grande mare. Un oggetto aerodinamico. Ed affusolato, al tempo stesso, con un alettone nella parte superiore. Cinque razzi nel suo retro, pronti a fare il fuoco delle circostanze. Senza neanche l’accenno di un conto alla rovescia, quindi, il velivolo fece partire i suoi motori. E con un solido boato, sfondò in rapida sequenza, la barriera del suono, la stratosfera ed i confini più remoti del pianeta Terra. Visibilmente soddisfatto, l’altro falco gridò una risposta al suo compagno. “Quando crescono…” Sembrò sottintendere grazie alla mimica del becco: “…Che gioia!”
Lo strano rituale, a voler essere sinceri, non è opera di bestie mai classificate da Linneo. Perché è frutto del pensiero della scienza e della tecnica moderne, nonché risultanza del volere di due miliardari assai particolari: Paul G. Allen, a suo tempo co-fondatore della Microsoft assieme a Bill Gates, e Burt Rutan, progettista aeronautico, per lungo tempo mente fervida al comando della Scaled Composites, una delle compagnie in grado di produrre gli aerei più strani di questa Terra. Il che spiega pienamente perché mai gli uccelli non presentino una sola piuma. Bensì sei motori Pratt & Whitney PW4000 da 205–296 kN, cannibalizzati allegramente da una coppia di Boeing 747 ormai prossimi al pensionamento. E due code trasversali cruciformi, totalmente indipendenti, talmente alte da richiedere la costruzione di strutture estremamente particolari presso una base aerea in Mojave, soltanto per pensare di costruirlo ed immagazzinarlo. Del resto, non l’avevamo ancora detto: l’apertura alare della “cosa” è di 117 metri; praticamente, si potrebbe parcheggiare al centro esatto di un campo da calcio ed a quel punto, le ali spunterebbero fuori ai lati. In effetti questo aereo, se vogliamo definirlo tale, è il più largo mai visto. E non è molto, che l’abbiamo visto: esattamente il 31 maggio, in effetti, la compagnia a lui omonima della Stratolaunch Systems l’ha presentato alla stampa, con grande risonanza mediatica internazionale. Ma il mostro, allo stato dei fatti attuali, non ha ancora preso il volo, evento previsto entro la fine del 2016. È inutile dirlo: siamo tutti in trepidante attesa.
Ecco dunque, la domanda: perché mai mettere assieme un aereo che in effetti sono due, uniti alla stregua una coppia di gemelli siamesi o per usare un’analogia più calzante, proprio come gli scafi di un catamarano? Struttura acquatica che, in effetti, ha il chiaro vantaggio di rendere più stabile un natante. Ma in cielo non aveva più avuto trovato utilizzi significativi dall’epoca della seconda guerra mondiale, con l’uscita di produzione del caccia pesante P-38 Lightning statunitense. La risposta, neanche a dirlo, si trova al centro esatto della questione, sotto l’ala condivisa (ehm…Il punto in cui si uniscono…Le ali?) che ospita un sofisticato sistema di aggancio fornito dalla Dynetics, al quale sarà possibile agganciare tutta una serie di velivoli incapaci di decollare in solitaria. Tutti appartenenti, come potrete facilmente immaginare, alla classe di apparati ottimizzati per un diverso e assai particolare tipo di volo: quello al di fuori dei confini terrestri. Proprio così, e proprio come avete “visto” in apertura: lo Stratolaunch serve a trasportare navi spaziali. Non è il primo, né l’ultimo, degli aerei pensati per questa specifica finalità. Il primo era stato concepito verso la metà degli anni ’70 e proposto alla NASA, con il nome di Conroy Virtus. Sarebbe stato il prodotto di due fusoliere di Boeing B-52 Stratofortress unite nella parte centrale, con una gondola in grado di contenere niente meno che il già imponente Space Shuttle. Ma il velivolo, che avrebbe avuto un’apertura alare di addirittura 140 metri, fu giudicato poco pratico e non venne mai effettivamente costruito. Per trovare un altro esempio degno di nota, quindi, occorre spingersi fino al ben più recente 2015, quando il team ingegneristico ai comandi di Burt Rutan, che allora lavorava ancora per la sua storica Scaled Composites, diede i natali al cosiddetto White Knight (Cavaliere Bianco). Un velivolo che potreste forse conoscere con il soprannome di “aereo spaziale della Virgin”.