La prova che la matematica non è soltanto un metodo finalizzato a incapsulare, ridurre e in qualche modo contenere la natura: in molti hanno trascorso la migliore parte della propria vita, tentando faticosamente di trovarla. I filosofi del Mondo Antico, primi a interrogarsi sulla forma materiale dell’universo. Gli studiosi dei fenomeni e gli artisti del Rinascimento. I primi utilizzatori del metodo scientifico, emersi da quel calderone d’idee e di tecniche ai princìpi dell’era moderna, che oggi siamo soliti chiamare Illuminismo. Laddove appare estremamente chiaro, per chi ha soltanto voglia di studiare il senso critico alla base della scienza, che se soltanto sparissero dal mondo i numeri con tutte quelle cifre, ciò non basterebbe a rendere impossibile un approccio logico allo studio delle cause e delle conseguenze; mediante l’attribuzione, successivamente effettuata, di un valore agli elementi di questa terra. 1, 2, 4, 6, 8, come le zampe di ciascun insieme di esseri viventi. 3, 5, 7, 9 etc, Il numero di vertici previsti nei cristalli provenienti dalla solidificazione di diversi tipi di sostanze. E al di sopra, così via a seguire: le volute di una singola spirale. Il numero di rami di un arbusto e le diramazioni di un intero fiume, i picchi che costituiscono la cima delle montagne. Le armonie del canto del passero solitario, tendenti all’infinito. Mentre per quanto riguarda quantità specifiche, ma relativamente meno elevate… Ecco, vi basterà abbassare il tenore delle vostre aspettative. Diciamo, insomma, che i vostri risultati possono sembrare un’approssimazione! Perché come tutte le strade portano a Roma, alcune operazioni sembreranno dare sempre lo stesso, identico risultato…
Ad esempio attribuiamo un numero arbitrario al nostro vecchio amico, il bruco verde come la sua foglia: 1. E sommiamo ad esso il succedersi del ritmo di un intero ciclo stagionale, ovvero 4, per giungere al numero delle nostre dita. Quindi dividiamolo per il numero di ali, elevato alle diramazioni tipiche di un gran paio di corna d’ungulato (cervo di campagna, cervo di montagna, fate un po’ voi). Una ricetta estremamente chiara, vero? Il cui totale sarà sempre 88, 89 o 90: apoteosi. E per chi non fosse pronto a crederci, basterà guardare in alto. Tra i raggi del Sole che filtrano oltre il tetto di quei rami, ove un tale Risultato ancora fluttua e vola, insinuandosi visivamente al centro esatto del nostro ragionamento. Guarda: è Diaethria, la farfalla della tribù Callicorini, particolarmente comune negli ambienti umidi del Sudamerica, ma non del tutto ignota anche in Messico e talvolta, fino in Texas, dove si spinge nel corso delle proprie esplorazioni migratorie senza un obiettivo estremamente preciso. Tranne di trovare, grazie all’uso dei suoi occhi sfaccettati, l’equivalente numero che incorpora il destino della propria stessa esistenza: chiaro segno, più di ogni altro, della compagna con cui mettersi a produrre la nuova generazioni d’uova, da attaccare sulla foglia della pianta ospite, affinché il mondo possa conoscere di nuovo il senso estetico della sua specie. E di che senso facile da fraintendere, quale eccezionale dualismo funzionale siamo qui a parlare: non molti ricordano, in effetti, quale sia il più importante tratto distintivo tra farfalle e falene. Non l’ora principale della loro attività (talvolta le prime si alzano in volo oltre il crepuscolo, e viceversa) né la quantità di colori presenti sulle loro ali (ci sono falene coloratissime) bensì il modo in cui si posano con le ali rispettivamente perpendicolari al suolo oppure parallele ad esso. Per mostrare, nel primo dei casi, lo speciale disegno nascosto al di sotto di una tanto funzionale simmetria!
sudamerica
Il segreto della vita nella valle della morte cilena
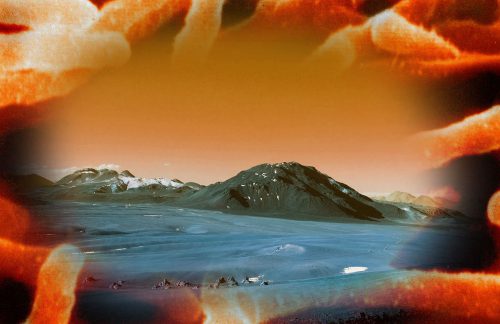
Essere privo di mente, senza occhi e senza orecchie, rimasto eternamente solo sopra il suolo arido di Marte. E con ciò voglio dire che il concetto d’individuo, ormai da tempo immemore, è per esso privo di significato, mentre ciascuna singola occorrenza della propria specie esiste in una sola monade continuativa, costituita dall’insieme plurimo dei suoi invisibili rappresentanti. Perché è questo il solo metodo, con cui i batteri possono riuscire a sopravvivere: mediante sforzo unico e totalizzante, di ogni microgrammo dell’enfatica biomassa, nella costruzione di un muro. La membrana cellulare che al confine delle cellule dei procarioti, ne difende il denso contenuto, d’acido desossiribonucleico, i mitocondri e tutto il resto, dalla polvere, dal Sole, dal pH della sabbia e dai protisti predatori. Ma non c’è nulla, in senso totalmente letterale, che potesse prepararli a questo: la calata di un lontanissimo parente, nei fatti più simile ad un fungo. Ed una profezia. Dell’orribile actinomicete (ord. Actinomycetales) creatura estremamente pervasiva grazie alle sue spore, che calando sopra il mucchio, ne inizia l’opera di distruzione sistematica. Diffondendo, a macchia d’olio, l’arma biologica più efficace di cui dispone; il feroce glicopeptide, che ogni membrana rende permeabile, smontandola sin dal più minuscolo mattone.
Una scena, questa, che potremmo facilmente rivedere (si fa per dire) altrove. Ovvero molto più vicino del pianeta Rosso ormai sempre più prossimo all’esplorazione umana, proprio qui nel nostro globo di terra ed acqua, presso il luogo che più d’ogni altro riesce a ricordarlo. Sudamerica, Cile, deserto dell’Atacama: terra super-secca grazie alla collocazione tra due alte catene montuose, le Ande e la Cordigliera della Costa, nonché battuto dal feroce anticiclone del Pacifico, capace a poche ore di distanza di far bollire le ossa o ghiacciare l’acqua all’interno di una bottiglia nel giro di pochissimi istanti. Un ambiente, insomma, che potremmo definire totalmente all’opposto della Vita per come siamo abituati a concepirla. Se non fosse, per citare lo scienziato sottovalutato di una celebre vicenda letteraria e cinematografica che “[Essa] trova, sempre, il modo.” Nelle crepe della terra ferita dalla luce ultravioletta, sotto sassi abbandonati a lato del sentiero, dentro buche impresse nel paesaggio da preistorici animali… E che maniera, quale splendido sistema di sopravvivenza!
Era l’anno 2008 quando un intero team di scienziati guidati dal biologo scozzese dell’Università di Newcastle Michael Goodfellow, si recò ad effettuare una ricerca che avrebbe cambiato per sempre la cognizione che avevamo di un simile luogo. Per l’isolamento sistematico, e tassonomico, dell’intera potenziale popolazione di queste creature largamente prive di studi pregressi, proprio per la natura inospitale e irraggiungibile del loro habitat d’appartenenza. Ciò che sostanzialmente nessuno, tra i diretti interessati e nell’intero mondo accademico riusciva tuttavia ad immaginarsi, fu a quel punto pura ed innegabile realtà: ecco proprio lì, nel luogo degli scheletri e del sale, una lista senza fine di creature totalmente nuove, ovvero appartenenti a specie prive di un nome e che tali sarebbero rimaste, a causa della propria incalcolabile ed imprevista varietà. Ma la parte forse più intrigante si sarebbe palesata successivamente, tra le mura sterili di un laboratorio. Dove il frutto di un così ricco raccolto, mescolato con intento sperimentale a batteri di provenienza più convenzionale, iniziò a produrre tutto attorno un’alone perfettamente circolare. Ebbene si: gli actinobatteri si stavano facendo largo nelle moltitudini, plasmando il proprio spazio come fatto da un coltello incandescente in un panetto di burro. Una strage senza nessun senso, tranne l’ira di chi vuole vendicarsi dei catturatori…
Lo spettacolare banchetto di terra dei pappagalli ara macao
Fondamentale tratto dominante nel carattere degli appartenenti alla tribù Arini, parte della famiglia tassonomica che include la maggior parte delle specie tropicali di “veri” pappagalli, risulta essere un profondo senso dei pericoli e delle ricompense. Per uccelli tanto imponenti e maestosi, il cui complicato ecosistema natìo, le foreste dell’America Meridionale, comporta comunque significativi attacchi da parte dei potenziali predatori, dalla picchiata fatale di un rapace all’agile balzo del giaguaro, sino all’assalto occasionale di scimmie particolarmente affamate o dispettose. Il che ha fatto, di tali volatili caratterizzati da fantasiose armonie rosse, gialle, verdi e blu, la perfetta personificazione piumata della prudenza, rendendo favolosamente rara l’occasione di vederli posati per lunghi periodi durante il giorno, lontano dai propri nidi o fori protettivi nel tronco degli alberi secolari. Fatta eccezione per una singolare, reiterata casistica, talmente diffusa da aver dato i natali negli ultimi anni a una particolare forma di bird watching estremo, capace di portare lo sguardo di tutti coloro che vantano un qualche tipo d’interesse in materia al cospetto di letterali dozzine, se non addirittura centinaia di questi esseri, temporaneamente assembrati a stretto contatto in un singolo luogo dall’evidente quanto palese vulnerabilità: l’affioramento di argilla su un lieve declivio chiamato in lingua spagnola collpa, o un’equivalente assolata radura totalmente priva di nascondigli.
E tutto questo per compiere uno specifico, quanto essenziale gesto: prelevare con le zampe dei piccoli grumi di fango minerale, da trasportare fino ai rami più alti degli alberi vicini. Prima di aprire il becco ricurvo e iniziare, pensierosamente, a trangugiarne quantità significative. Si tratta di geofagia: l’abitudine, in effetti tutt’altro che rara nel mondo animale, consistente nell’assumere come parte della propria dieta del materiale del tutto inerte, con il più vasto ventaglio di possibili finalità. Vedi il caso, nell’universo volatile e anche nel caso di plurimi pappagalli, della costituzione del ventriglio o mulino gastrico, ovvero uno spazio all’interno dell’apparato digerente in cui il bolo alimentare possa essere letteralmente sminuzzato, dall’alta quantità di sassolini e ghiaia derivanti da un così ancestrale istinto. Ciò detto pappagalli come gli Ara possiedono un becco particolarmente affilato ed efficiente, quasi a livello di una vera e propria dentatura, nel preparare al processo digestivo la frutta, i fiori, il nettare e il resto dei materiali vegetali del resto particolarmente teneri, che sono soliti assumere come parte della propria dieta nell’habitat naturale di provenienza (fatta eccezione per alcune tipologie di semi legnosi, che del resto schiantano fragorosamente grazie a una così raffinata arma evolutiva). Il che ha portato, per lungo tempo, gli scienziati ad interrogarsi su quale, in tutta sincerità, potesse essere l’obiettivo perseguito nel corso di questi celebri pranzi a base di terra rossiccia. Tanto che prima di entrare nel merito della questione, possiamo dare spazio all’usuale quanto drammatica premessa. Secondo cui, ancora oggi e nonostante i notevoli progressi compiuti dai metodi d’approfondimento accademico, persiste innegabilmente qualche significativo grado di mistero…
Il complicato canto dell’insetto più spinoso d’Ecuador
In bilico sopra la foglia, sin dall’epoca Giurassica, giaceva l’invitante pasto verde ed arancione. Ma il pipistrello saggiamente, prima di calare sulla sagoma evidente, fece un giro e quindi un altro, premurandosi di ponderare la questione. Poiché l’esperienza di chirottero, dolorosamente guadagnata, gli insegnava che quella particolare “cosa” aveva un’arma di difesa in grado di renderla indigesta: il fatto di essere, praticamente, un rovo con le zampe arcuate, assai difficile da masticare. Diavolo di una cavalletta spinosa, o in un’altra lingua, spiny devil katydid. Trinomio che in effetti può adattarsi a tutti gli esponenti di un genere fatto recentemente oggetto di studio da parte degli umani, composto dalle 7 varietà diverse che si accompagnano al termine latino Panacanthus: gibbosus, intensus, lacrimans, spinosus, varius, pallicornis ed ovviamente il sopra mostrato cuspidatus, grazie alla puntuale ripresa in HD del canale di Andreas Kay. Che forse non arriverei a definire specie maggiormente rappresentativa, ancorché grazie al suo insolito aspetto risulti essere, di certo, una delle più stupefacenti. Con le spine sulle zampe, sulla testa ed il pronoto (primo segmento del torace) tanto preminenti da arrivare a biforcarsi in vari luoghi e particolarmente in cima alla sua fronte, in quella che parrebbe costituire, in ottima sostanza, la più piccola ma nondimeno affascinante delle corone. Struttura, quest’ultima, ritenuta lungamente funzionale al tipico confronto tra maschi, nella continua lotta per la sopravvivenza dei propri geni. Questo almeno finché nella seconda metà degli anni 2000, attraverso una serie di studi accademici condotti nell’area geografica sudamericana, non si arrivò a riconfermare quanto già lungamente sospettato: che il principale metodo impiegato da queste cavallette per affascinare il gentil sesso è in realtà di tutt’altro tipo, appartenendo in pieno alla sfera sonora e conseguentemente, uditiva. Grazie all’impiego della particolare duplice struttura integrata nella forma delle ali, che prevede alla metà esatta di esse una striscia lievemente increspata chiamata lima contrapposta al plettro, o raschiatore, situato invece nella parte posteriore. Al che strofinando la destra con la sinistra, l’insetto produce un sibilo altamente caratteristico e riconoscibile, che può al tempo stesso essere un fattore indicativo di ottima forma fisica (garantendo in questo modo l’accoppiamento) presentando tuttavia di contro un risultato altamente problematico per la sua sopravvivenza: il fatto di offrire, potenzialmente, l’opportunità al pipistrello d’intercettarlo. A meno che specifiche risorse evolutive collaterali, come sopra menzionato, non risultino bastanti a compensare una simile vulnerabilità…




