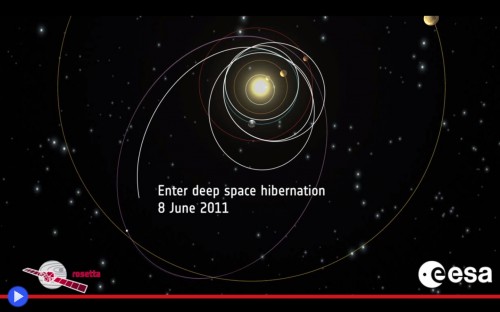Sembrano gridarlo ai quattro venti, renderlo palese con la forza dei propri semplici gesti: tutto quello che pensate di sapere sul Sistema Solare, non è proprio Sbagliato…Ma nemmeno utile a costruirvi un visione che risponda alla realtà. E la colpa, se vogliamo, è tutta degli illustratori che ci hanno portato, in anni ed anni di abbellimenti visuali, verso quel modello: la grande sfera fiammeggiante al centro. Una, due, tre, quattro palle dalle dimensioni molto minori, separate l’una dall’altra per lo spazio di qualche centimetro a dir tanto (Mercurio, Venere, Terra, Marte) ed altre quattro invece, dalle proporzioni medie, nonché vivacemente colorate: Giove, Saturno, Urano, Nettuno. Se conservate poi un ricordo del periodo antistante al 2006, a questo club ristretto si sarebbe aggiunto il “piccolo” Plutone, oggi declassificato a pianeta nano, poiché parte in realtà della lunga serie di oggetti rocciosi che formano la cintura asteroidale di Kuiper, analoga a quella interna della fascia principale. E persino lui così azzurrino (chissà poi perché) nel trionfo del paradossale, sarebbe stato lì, con l’ellisse del suo moto alla distanza media di 6 milioni di Km dal Sole circa, forse giusto un po’ di lato, su quel foglio. Messo, al massimo, lievemente in disparte. Il che non sarebbe stato un grandissimo problema, se almeno la rappresentazione convenzionale dell’intero meccanismo fosse in scala. Ma il fatto è che le vertiginose distanze che separano ciascuno di questi corpi, nella loro danza gravitazionale, è così estesa da sfuggire a degne rappresentazioni. Se volessimo raffigurare le distanze rilevanti, i pianeti dovrebbero essere puntini o al massimo cerchietti, e la pergamena usata per raffigurarli, srotolabile, fino alla lunghezza di diversi metri di assoluto nulla. Proprio per questo, le migliori rappresentazioni sono quelle digitali. Però talvolta, stanchi di guardare luci fittizie riprodotte dentro a un monitor, viene anche la voglia di dare una forma fisica a quanto descritto fino ad ora: il vero volto del Sistema. Più che altro perché, utilizzando un punto di osservazione inserito all’interno di un modello in scala, si potrà provare l’emozione di osservare ciascun elemento costituente, alla dimensione relativa che esso veramente avrebbe, nel corrispondente punto dello spazio interplanetario.
Ciò significa, come sapientemente dimostrato verso il termine del video di Wylie Overstreet ed Alex Gorosh, To Scale: The Solar System, che qualcuno potrebbe mettersi vicino a quella biglia che è nella finzione il pianeta Terra. Mentre il suo amico solleva in alto, con gesto teatrale, il mega pallone da spiaggia usato per il Sole. Mentre quest’ultimo, sapientemente manovrato, coprirà perfettamente il disco della nostra stella sopra l’orizzonte, nella perfetta riproposizione di un’eclisse fatta in casa, totalmente soggettiva quanto degna di essere narrata. Il concetto non è, in realtà, del tutto nuovo. Di modelli accuratamente proporzionati del nostro vicinato cosmico ne esistono dozzine: nei musei statunitensi, presso le istituzioni di studio e ricerca. Ad Elrlenbach sul Main, nel land della Baviera, ce n’è uno in scala 1:1.000.000.000, con sfere di metallo poste sopra grandi piedistalli. Il Sole, naturalmente, è dorato. L’università del Colorado vanta un progetto che si estende per l’intero campus, dal planetario di Fiske fino al termine del viale Regent Drive. Qualche volta, tali creazioni diventano dei veri monumenti, con ciascuna sfera montata in alto sulla strada, dislocata lungo uno spazio tra una città e l’altra, come fatto nell’esemplare vantato dallo stato del Maine, che misura complessivamente ben 64 Km e mezzo, dalla comunità di Presque Isle ad Houlton, sul confine con il Canada. Mentre il più imponente di simili costrutti si trova in Svezia, lungo diverse città presso la costa del Mar Baltico. Il Sole, qui, è rappresentato dallo stadio ad emicupola dell’Ericsson Globe, il più grande edificio del suo tipo, mentre i diversi pianeti sono attraenti opere commissionate ad artisti di fama, ciascuna nell’esatta scala di 1:20.000.000. Pensate, per iniziare a rendervi conto delle distanze relative, che i quattro pianeti del Sistema interno sono tutti a Stoccolma, mentre gli altri si trovano ad Uppsala (73 Km dal Globe) Gävle (143 Km) Söderhamn (229 Km) e così via. Per rispettare le dimensioni relative, quindi, la terra misura 65 cm di diametro, mentre Plutone appena 12. Il modello da due metri e mezzo di Urano, per motivi forse dovuti al doppio senso del suo nome, è stato più volte vandalizzato.
Ma il fatto è che qualsiasi ricostruzione di questo tipo, per sua inerente necessità, deve sempre fare i conti con le distrazioni dell’ambiente circostante: strade, lampioni, edifici… Mentre nell’idea di questi due autori, si è cercato di fare un qualcosa di totalmente diverso: il più piccolo modello che fosse anche osservabile da lontano, collocato in uno dei luoghi maggiormente affini al vuoto cosmico che abbiamo sulla Terra: il vecchio bacino endoreico (ex-lacustre) del deserto Black Rock, a decine e centinaia di chilometri dal più vicino centro abitato.