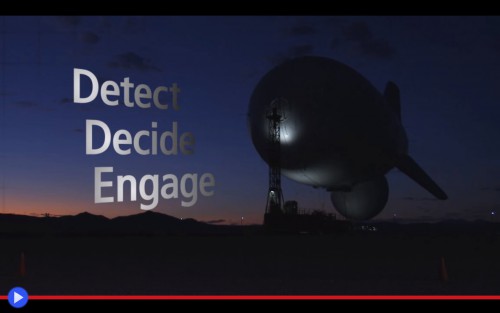Viene un momento, nel comune scorrere della propria vicenda personale, in cui più di ogni altra cosa si desidera di essere altrove. Durante un’interminabile riunione di lavoro, sui banchi di una giornata scolastica piuttosto complicata, in mezzo ad un ingorgo lungo quanto Jörmungandr, il grande serpente che circonda gli oceani di Midgard, scuotendo la propria coda assieme ai continenti. E forse nessuno ha mai provato questo sentimento di auspicabile dislocazione maggiormente di chi, al proprio risveglio repentino, si è trovato coinvolto nel pieno di un disastro naturale, come un’alluvione o un terremoto. Quando sarebbe bastato, quella particolare notte, decidere di andarla a trascorrere in villeggiatura, o come ospiti di amici, o magari semplicemente a bere al bar, per poter correre sul viale incolumi, gridando a pieni polmoni la propria rabbia ed il sollievo per la piega presa dagli eventi. Ma se invece abiti al quarto, quinto piano? Se l’edificio che protegge la tua casa non è stato costruito esattamente con materiali ad alta resistenza, magari perché è antico, oppure qualche predecessore della sfera tecnica, ahimé, ha ceduto alla tentazione di arricchirsi con risparmi sul progetto? Se quando viene quel fatidico momento, sorpreso ed assonnato, non hai che pochi secondi per balzare fuori dalla porta, percorrere le scale fino all’unica, remota via d’uscita…Non è detto che ti salvi. Diciamo che ci vuole, quanto meno, un certo aiuto dalla dea Fortuna. Mentre secondo le statistiche, stando alla legge dei grandi numeri, salvare vite significa trovare un sistema che sia, letteralmente, fool-proof (a prova di errori) e quindi adatto a trarre fuori dall’impellente grama chiunque, inclusi gli individui meno pratici, scattanti o quelli con il sonno più pesante. Il che significa, sostanzialmente, che nel caso qui descritto l’unica remota soluzione è questa: potenziare il letto stesso. Renderlo, grazie all’impiego di una straordinaria soluzione tecnologica, in grado di chiudersi di scatto, proteggendo il suo occupante da qualsiasi crollo, non importa quanto rovinoso e/o devastante.
Come per le altre proposte dell’azienda russa Dahir Insaat, di proprietà dell’industriale ed ingegnere Semenov Dahir Kurmanbievich, questo letto futuribile non viene offerto al grande pubblico soltanto sulla carta, bensì accompagnato da un esauriente dimostrazione video, creata in computer grafica decisamente competente, se non proprio a livello dei più costosi e popolari videogiochi. Lo scenario è per certi versi strano, eppure in qualche maniera fin troppo plausibile: ci sono alcuni personaggi, fuoriusciti direttamente dall’ultimo episodio di The Sims, che riposano beati all’interno di enormi stanze da letto, sopra dei plinti degni di una piramide però siti all’interno di un palazzo dall’aspetto conforme a quello della maggior parte delle abitazioni di epoca sovietica, che costituiscono da decenni la periferia di grandi città come Mosca o San Pietroburgo. D’un tratto, senza alcuna soluzione di continuità, la telecamera si sposta all’esterno in quanto, oh, no! La terra inizia a tremare. Montaggio alternato: fuori-dentro; mentre già le pareti s’incrinano ed iniziano a crollare sopra loro stesse, il giaciglio sopraelevato dei fortunati condòmini dimostra il suo segreto. Come una tagliola, o ghigliottina, quello reagisce a dei sensori non mostrati (simili a…Sismografi?) e ingloba la persona che dorme, assieme a materasso, cuscini, coperta e tutto il resto. Un portello quindi viene chiuso automaticamente nella parte superiore, rendendo la scatola del tutto indistruttibile, non importa il peso delle macerie che vi crolleranno sopra. Ora, naturalmente questa soluzione non è sempre la migliore: è possibile immaginare casi in cui, l’improvviso scoppio di un incendio a seguito del terremoto, avrebbero reso maggiormente consigliabile una fuga precipitosa. Oppure edifici talmente alti che il loro crollo, non importa quanto si è protetti, comporterebbe un contraccolpo grave per gli occupanti della cassaforte umana. Per lo meno, un’ampia selezione di rifornimenti è stata inclusa sotto il giaciglio, permettendo ipoteticamente la sopravvivenza per periodi prolungati sotto le macerie, per un tempo sufficiente ad attendere i soccorsi. Inoltre, è ragionevolmente probabile che l’occupante della capsula possa intervenire sui comandi, aprendola immediatamente quando ritenuto necessario. Purché i detriti causati dal crollo non blocchino il coperchio con il loro peso…