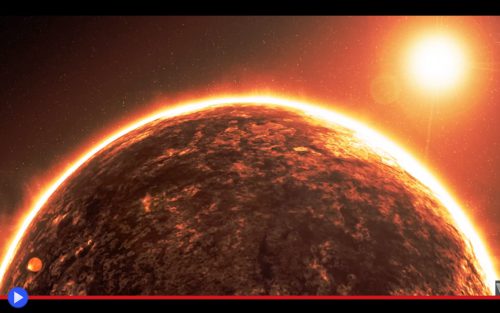Una delle immagini più shockanti e terribili del mare, spesso condannata anche dai non ecologisti, è il periodico ripetersi di un’usanza, comune alle isole Faroe tra Inghilterra e Norvegia ed al Giappone della città di Taiji. Quel momento in cui il mare si tinge di rosso, mentre le rispettive popolazioni si radunano sulla spiaggia, facendo strage di grandi quantità di balene pilota, nel primo caso, e per lo più delfini nel secondo. Animali particolarmente in grado di suscitare lo sdegno del grande pubblico, perché considerati simili a noi, intelligenti, dalla vita relativamente lunga e con la capacità di comprendere a pieno la loro triste condizione. Nonché soprattutto, si presume, in grado di soffrire in maniera piuttosto intensa. È il realizzarsi di una visione tanto truculenta da essere oggettivamente difficile da razionalizzare, anche volendo accettare l’importanza delle tradizioni marittime e l’effettiva sostenibilità di simili iniziative. Mentre il resto nel mondo globalizzato, dal canto suo, non trovando simili orpelli abbinati al proprio concetto di civilizzazione, guarda in entrambe direzioni con sdegno e non senza una certa dose di auto-compiacimento, nella presa di coscienza dell propria maggiore attenzione alla cosa naturale. Il che appare del tutto vero, finché non si assiste a fenomeni come questo: un uomo, noto come The Fish Whisperer (Colui che sussurra ai pesci) impugna la telecamera presso la foce del Colorado River, nell’estremo meridione del Texas, dove una sottile striscia di terra separa un braccio di mare dal resto del golfo del Messico, creando una sorta di vasta piscina, nota col nome di baia di Matagorda. In cui alcuni canali costruiti e gestiti dall’uomo permettono alle imbarcazioni di navigare verso l’entroterra. Le quali talvolta, è inevitabile, vengono seguite da una certa quantità di pesci, che ormai da tempo hanno qui ricreato il proprio habitat ideale. Menhaden del Golfo per essere più precisi (Brevoortia patronus) animali non particolarmente rari, speciali o preziosi da un punto di vista dell’economia, appartenenti alla stessa famiglia delle aringhe. Ma semplicemente fondamentali per la catena alimentare oceanica, poiché costituiscono uno dei pochi anelli tra il plankton e molte forme di vita più sofisticate, come pesci persici, squali, balene ed uccelli pescatori. Tanto più grave appare dunque questo improvviso evento, in cui migliaia, per non dire milioni di questi esseri, tutto d’un tratto, si sono ritrovati a morire accumulandosi ai lati del canale, lasciando il nostro autore del video letteralmente senza parole. E cosa potrebbe mai dire, dinnanzi ad uno degli episodi di annientamento collettivo più totali ed imprevedibili del pianeta? Non è la prima volta che questo succede: ci sono almeno altri due casi registrati, nel 1995 e nel 2005. Ogni 10 anni, all’incirca, ogni singolo nuotatore del canale sembra passare istantaneamente a miglior vita, senza ragioni palesi ed evidenti. Non si tratta per niente, ad esempio, del rilascio improvviso di sostanze velenifere ad opera di qualche impianto industriale. Ma di un qualcosa di molto più indiretto…
È un fatto largamente noto, ma poco regolarmente approfondito, che i pesci abbiano effettivamente bisogno di respirare ossigeno, proprio come noi esseri di superficie. Le branchie non li esonerano da tale necessità, permettendogli piuttosto di effettuare la separazione delle molecole ad un livello cellulare, metabolizzando l’acqua invece di limitarsi a berla. Il che significa, incidentalmente, che il contenuto di quest’ultima deve essere sufficientemente adatto ad una simile operazione. E non è sempre, ne automaticamente così, come ampiamente esemplificato dall’esistenza dell’apparato di aerazione (o bubbler) per gli acquari, che si occupa di pompare in esso una quantità adeguata d’aria. Ora quando l’acqua è stagnante, o eccessivamente piena di pinnuti abitanti, può succedere che l’ossigeno finisca per esaurirsi. E che tutti i pesci, nessuno escluso, muoiano soffocato. Benché a dire il vero, questo non è l’unico fattore a pesare sul disastro di Matagorda Bay. Poiché a dare il colpo di grazia ci ha pensato, in effetti, un’improvvisa e incontrollabile fioritura di alghe, come i cianobatteri, i dinoflagellati, i coccolitofori e le diatomee. E sebbene possa sembrare strano che organismi in grado di produrre e riciclare l’aria respirabile, in ultima analisi, siano proprio la causa dell’evento, occorre anche considerare con il loro arrivo la formazione conseguente di substrato, privo di luce e quindi fotosintesi, in cui l’ossigeno semplicemente cessa di arrivare. E volete sapere la causa di tutto questo? Praticamente ovvio: l’uomo.
La strategia del pinguino tattico esplosivo
Snake-maru controllò il dispositivo di comunicazione codificata integrato nel suo auricolare, verificando che la ricezione fosse ideale. Quindi iniziò a sub-vocalizzare il messaggio, assicurandosi che dalla bocca non uscisse neanche il più impercettibile sussurro. “Aquila di Fuoco, qui Snake. Sono appena penetrato nella fabbrica di biciclette che fa da copertura per l’hangar del Mecha Gear. Ho eluso le telecamere ed il nemico non ha rilevato la mia presenza.” Un attimo di pausa, mentre una pattuglia girava nel salone d’ingresso, quindi voltava per il corridoio in direzione della sala mensa. Per qualche strana ragione, le conversazioni tra lui e la base tendevano ad essere piuttosto prolisse e circonlocutorie. “Ma ora c’è un problema: di fronte al pannello di sicurezza, due guardie armate con scafandro protettivo anti-radiazioni. La mia pistola a tranquillanti non avrà effetto su di loro…” Mentre aspettava una risposta, il più segreto agente speciale al servizio dell’esercito degli Stati Uniti vagliò attentamente le diverse opzioni. Poteva, naturalmente, usare il fucile d’assalto, caricando frontalmente l’ostacolo e rimuovendolo alla radice. Ma il suo intuito superiore gli diceva che così avrebbe attirato attenzioni indesiderate. In alternativa, avrebbe dovuto sfruttare uno stratagemma. Il suo cervello frutto della selezione genetica e gli esperimenti segreti sulla clonazione umana elaborò quindi una possibile soluzione per distrarre i problematici soldati. Avrebbe potuto emettere un suono, lanciando dietro l’angolo un caricatore, quindi nascondersi all’interno dell’infallibile scatola di cartone pieghevole, da cui non si separava mai. Ma persino questo, avrebbe richiesto diversi secondi. Come avrebbe potuto allungare i tempi del suo dirottamento? In quel momento, il codec vibrò: “Snake-maru, qui Aquila. Il tuo problema non è insormontabile. Devi credere in te stesso! Ricordi il film di guerra del 1961, i Cannoni di Navarone, con la regia di John Lee Thompson e una grande prova di recitazione da parte di Gregory Peck? C’era una scena in cui i protagonisti, per superare il tedesco in cima alla scogliera gli lanciano addosso un pitone. Snake, tu non devi semplicemente distrarre le guardie. Troverai la risposta nel potere carismatico degli animali.” A quel punto, l’uomo sul campo rimise in tasca il caricatore e appoggiò a terra lo zaino. D’un tratto, si era ricordato di un libro sottratto durante la sua infiltrazione nella biblioteca della base, con il titolo di “Kami no karakuri kamikara de asobo!” Perfetto, pensò fra se e se. Voltando febbrilmente le pagine, tenendo sempre d’occhio il fondo del corridoio, Snake trovò rapidamente la pagina ritenuta migliore. Quindi la rimosse, ed iniziò febbrilmente a piegare la sagoma del pinguino. Con le armi deposte a terra, seguendo attentamente le istruzioni, finché d’un tratto, all’improvviso, non si trovò in mano l’oggetto desiderato. Usando l’elastico che teneva la coda dei suoi capelli, gli diede il tocco finale. Osservandolo non poté esimersi dal sussurrare con voce roca per via dei sigari “Ka-kawaii…” (Carino). Prima di gettarlo a terra e schiacciarlo con lo stivale. Operazione compiuta. Ora il pupazzo aveva la forma di uno shuriken, la proverbiale stelletta ninja, pronta per essere lanciato verso l’obiettivo desiderato. Trattenendo per un secondo il respiro, Snake assunse la posa plastica necessaria…
È un giocattolo. È un automa. È anche una bomba, ma non del tipo mirato a far danni. Serve, piuttosto, ad emanare un certo senso d’indiscutibile presenza, una suggestione stranamente graziosa. Sorprendere gli spettatori con il movimento. Il che lo classifica, in una singola parola, come una sorta di karakuri. L’automa tradizionale giapponese, usato nel corso degli spettacoli popolari o nelle case dei grandi signori, o ancora nei templi, per intrattenere i fedeli con rappresentazioni di personaggi o vicende prelevate dal folklore locale. Ma ciò lo rende in effetti, davvero unico nel presente caso, è il materiale con cui viene costruito: nient’altro che semplice carta, inchiostrata sulla base del soggetto di volta in volta selezionato. Perché fa parte di una lunga serie di personaggi, progettati e disegnati da Haruki Nakamura, un vero e proprio gigante di questo settore. Artista rinomato nel suo paese, con diverse mostre all’attivo e almeno una partecipazione al Japan Media Arts Festival (2010) in qualità di scelta della giuria, per non parlare delle svariate collaborazioni pubblicitaria con aziende di larga fama, l’autore è assurto alla fama internazionale grazie proprio alla pubblicazione di una serie di libri, in cui la sua particolare abilità dell’ingegneria cartacea (come lui stesso ama chiamarla) veicolava quest’antica sapienza in un formato piatto e più facilmente trasportabile. Un po’ come i mobili dell’Ikea. Ma poiché i suoi piccoli personaggi avevano tutti, nessuno escluso, la scintilla del movimento, egli decise di chiamarli kamikara, da kami (紙) carta, e le prime due sillabe in alfabeto katakana (カラ) che compongono la parola karakuri. L’effetto risultante è notevole. Sfogliando il testo sopracitato o uno qualsiasi degli altri sei elencati sulla sua homepage ufficiale (ospitata sull’antico portale Geocities, tanto per tornare indietro con la memoria) si scopre un mondo di esseri ad apertura automatica, squali che mordono giocosamente le dita infilate in una busta postale, coccodrilli che nascondono in bocca rane dal grande sorriso, uova spigolose con il pulcino a serramanico incorporato… È un vero trionfo della più incredibile fantasia.
Il gemello segreto che insegue il Sole
Tutto appariva normale, nel braccio periferico del disco della galassia. Ma se lo si guarda da abbastanza lontano, è praticamente sempre così… Quale enorme supernova, che incomparabile disastro, potrebbe risultare abbastanza forte da scuotere in un dato momento l’agglomerato di un milione di stelle? Ogni cosa è importante, in senso cosmico eppure da un certo punto di vista, proprio per questo, quasi niente lo è davvero. Una simile situazione cambia radicalmente soltanto quando un evento si analizza nello specifico, dal particolare verso l’assoluto, immaginando il punto di vista di chi deve vivere (o non-vivere) con le conseguenze di simili cause spropositate. Eppure, come nel caso delle antipatie e differenze tra antiche divinità, che condussero a guerre apocalittiche nell’era delle antiche mitologie, nessuno poteva davvero profetizzarlo. Quando d’un tratto, trascorsi i canonici 26 milioni di anni, ritornò lui. L’astro cupo delle profondità galattiche, una silenziosa nana grigia dalle emissioni praticamente impercettibili, passando attraverso l’agglomerato della nube di Oort. Colui o colei che da sempre aveva condotto un’esistenza del tutto solitaria, senza influenzare o essere influenzato da chicchessia. Tranne che in quei singoli e rari, ma regolari casi, in cui oltrepassando il velo glaciale, era sbucata nell’oscurità oltre l’ultimo dei pianeti. Trascinandosi dietro una certa quantità di meteore e comete. Stiamo parlando, sia chiaro, di un qualcosa di largamente ipotetico. Una risposta, piuttosto che la domanda, relativa al perché, effettivamente, possa essersi verificata a più riprese l’estinzione di un parte significativa della vita terrestre. Che fa da corollario alla celebre teoria del grande impatto, andando ad analizzarne la remota e poco luminosa ragione: la vendetta di un fratello. Il ritorno di un dio offeso. Colui che nascendo assieme alla nostra stella, aveva avuto la peggio, crescendo debole e malaticcio.
Il come e perché ciò potesse essersi verificato, fin dall’elaborazione di questa sfrenata ipotesi verso la metà degli anni ’80 e la denominazione dell’oggetto col nome piuttosto suggestivo di Nemesis, sono rimasti largamente ignoti alla scienza. Finché lo scorso 28 aprile non è stato pubblicato, sul server online dell’università di Cornell, un nuovo studio realizzato da Steven Stahler, astronomo di Berkeley, e la sua collega Sarah Sadavoy, mirato a presentare un’analisi dell’indagine astronomica di tutte le protostelle della nube molecolare di Perseus, sita a circa 230 parsec dal nostro sistema solare, un’operazione denominata VANDAM (VLA nascent disk and multiplicity survey). La precisa catalogazione, sostanzialmente, di una vera e propria forgia galattica all’interno della quale si verificano la serie di reazioni e coincidenze alla base della nascita di un corpo astrale del tutto nuovo. Il procedimento dell’elaborazione di una statistica matematica, si sa, è la strana prassi per cui il frequente verificarsi di un qualcosa lo rende più probabile in futuro. Oppure, in casi ancora più privi di una logica generativa, si presume succedere l’esatto contrario. Fatto sta che all’ennesimo spalancarsi di una simile finestra sull’infinito, in molti casi la sola che abbiamo, è apparso evidente come la maggior parte delle stelle neonate di classe spettrale G2 di Perseus, ovvero le più simili alla nostra, apparissero come parte di un sistema binario distante. Il che voleva dire, sostanzialmente, che esse ruotavano l’una attorno all’altra, a una distanza di circa 500 unità astronomiche, che poi sarebbero 17 più della distanza che c’è tra il Sole e il suo ultimo pianeta, Nettuno. Questo perché, come ampiamente dimostrato dai radiotelescopi del New Mexico usati nel corso del sondaggio, per ciascuna formazione stellare era presente una concentrazione molecolare nota come “ammasso denso” simile a un uovo con due tuorli distinti. Talvolta più distanti, e quindi propensi a separarsi per l’effetto della forza centrifuga rotativa, e qualche altra invece estremamente vicini, inevitabilmente destinati a formare sistemi multipli come quello della vicina Alpha Centauri. Ma il caso del Sole e di Nemesis, per inferenza, dovrebbe essere ancora diverso, ovvero quello di una delle due parti che assorbe una simile quantità di materiale da subordinare la sua controparte, limitando le sue dimensioni sufficientemente da farla restare intrappolata nel suo campo gravitazionale. Con le succitate conseguenze che purtroppo, noi già ben conosciamo. È una strana correlazione di fattori, che ci permette di comprendere qualcosa del nostro più prossimo vicinato attraverso l’osservazione di una realtà sita ad oltre 700 anni luce di distanza. Il che significa, incidentalmente, che stiamo osservando il passato. Ma questo, come si dice, è tutto un’altro paio di maniche…
La storia dei 40 ippopotami di Pablo Escobar
C’è un vecchio modo di dire dalla difficile attribuzione, tipico di molti film e personaggi statunitensi, che recita: “Nessuno pensa a se stesso come il cattivo.” La quale frase, il più delle volte, trova una diretta applicazione nel mondo reale. Guardate, a tal proposito, la figura del più grande trafficante di cocaina nella storia della Colombia e a dire il vero, probabilmente del mondo intero: l’uomo “del popolo” di Medellín, che nel corso dei suoi 44 anni di vita aveva costruito un’impresa di produzione e traffico in grado di fatturare all’apice del suo successo più di 70 milioni di dollari al giorno, più di Facebook, Starbucks o l’intero paese del Paraguay, oltre a diventare (brevemente) una figura politica inspiegabilmente amata. Spietato assassino, rapitore di persone famose, terrorista quando gli fece comodo, organizzatore di crimini particolarmente efferati. Ma questo, dopo tutto, era in un certo senso dovuto, vista la sua professione. No? Mentre se qualcuno gli avesse chiesto che cosa desiderava dal mondo, egli avrebbe forse risposto “Niente di che. Tutto quello che chiedo… È soltanto essere lasciato in pace.” O almeno questo è il tipo di personalità che hanno voluto far emergere nella serie Tv Narcos di Netflix, andata inizialmente in onda nel 2015, basata almeno in parte su un’evidente ricerca storica associata a diversi momenti speculativi e di fantasia, ma quasi mai del tutto azzardati. Se vogliamo giudicare dalle fonti disponibili online. Resta tuttavia indubbio che alcune delle sue gesta, per mere ragioni di budget, non siano state analizzate come avrebbero potuto. Sto parlando del come in effetti costui spendesse le sue ingenti risorse finanziarie, della vita di eccessi e follie che amava condurre, circondato dai più sfrenati simboli dell’opulenza concepibili secondo la sua cultura e visione delle cose. Ci sono, si, alcune scene con degli animali. Girate, per lo più, presso una villa architettonicamente piuttosto interessante, in realtà scelta per la sua somiglianza ad un luogo realmente esistito: il complesso, oggi largamente in rovina eppure ancora visitato da grande quantità di turisti, della rinomata Hacienda Nàpoles, sita all’incirca 155 Km a ovest di Bogotà. Una casa coloniale con un ampio terreno di 20 Km quadrati, che il trafficante aveva acquistato negli anni ’80, con l’obiettivo di trasformarla in un vero e proprio luogo dei sogni. Propri, e dei suoi due giovani figli. Il paragone con il celebre ranch di Neverland, posseduto a suo tempo da Michael Jackson, assolutamente coévo, è per certi versi utile; benché il cantante Pop statunitense avesse preferito un’estetica ed attrazioni da luna park, mentre il criminale sudamericano, per sua innata prerogativa, avesse scelto di dedicare la maggior parte del suo grande spazio a uno zoo privato. Con bestie come elefanti, giraffe, zebre, uccelli esotici ed ippopotami. Quattro di questi ultimi, per essere più precisi: tre femmine e un maschio. Ma non per molto.
Il problema essenziale dell’intera faccenda è che l’ippopotamo, dal punto di vista evolutivo, è una creatura adattata a sopravvivere in un habitat per lo più ostile. Animale acquatico nel più secco dei continenti, tanto forte e grosso da essere impervio ai predatori ma che deve costantemente proteggere i cuccioli e il territorio. Ora immaginate una simile creatura, trasferita nell’ambiente tropicale della Colombia, in mezzo a foreste accoglienti percorse da fiumi spropositati. Sarebbe un po’ come portare una famiglia di cavalli nel mezzo di un’enorme prateria. O un ratto nel sistema fognario di una grande città moderna. Successe così che successivamente al 1993, l’anno in cui Escobar venne infine trovato dalla polizia ed ucciso nel corso di una sparatoria, l’hacienda restò per un certo periodo del tutto priva di amministratori. Confiscata da un governo che non aveva l’inclinazione o i fondi per realizzarci qualcosa di valido, il complesso cadde progressivamente in rovina, mentre molti degli animali perivano o venivano liberati. Ma non loro: gli ippopotami anzi, incoraggiati dal clima, incrementarono drammaticamente il ritmo della loro riproduzione, arrivando a produrre un cucciolo l’anno. Quando nel 2005, finalmente, venne nominato un amministratore del bene pubblico ed esso fu trasformato, fra tutte le cose possibili, in un surreale “museo del crimine” dedicato ad Escobar, i grandi mammiferi erano ormai svariate decine. Eppure, non erano tutti lì, almeno a giudicare dai numerosi avvistamenti di “strane creature tozze dalle piccole orecchie” lungo l’antistante fiume di Magdalena, il principale corso d’acqua navigabile di quest’area geografica, a volte chiamato la Route 66 sudamericana. La Colombia era effettivamente diventata il primo paese non africano ad avere una popolazione selvatica di ippopotami. La leggenda dello Zar della cocaina continuava, tanti anni dopo la sua dipartita…