Oltre il fiume dei giganti, sopra i rami della grande quercia, il demonio della valle rifletteva in merito al motivo stesso della sua esistenza. In più di una maniera. Silenzioso, immobile, invisibile, attento, agile, minuscolo tra i fili… Da ogni punto di vista, tranne la preparazione a fare il suo dovere tra i complessi macchinari del mondo: percepire l’attimo della fatale vibrazione. Affinché ciò che transitava, diventasse momentaneamente immobile. Perfettamente stabile nel grande flusso dei momenti. Giusto il tempo necessario per avvicinarsi, e dare inizio alla sua opera perfettamente calibrata sulla base del bisogno. Poiché se un ragno di per se possiede quattro paia di zampe, certamente il paio più importante può essere soltanto il primo. Con cui avvolge rapido la mosca, la formica e il moscerino. Incapaci di capire l’ora ed il momento del pericolo, finché non è già tremendamente tardi per poter pensare ancora all’indomani. Ma il concetto stesso di questa creatura, intesa come l’olotipo o allegoria di un intero genere, denominato nel 1881 Thwaitesia dal barbuto zoologo Octavius Pickard-Cambridge, è che questi non conosce neanche la necessità di essere furtivo. In quanto possiede, nel suo stesso corpo, il principio e il metodo di un potentissimo segreto. Perché mimetizzarsi, quando si può riproporre il proprio stesso ambiente circostante agli occhi di colui che cerca la tua presenza? Perché nascondersi, quando si è capaci di cambiare in caso di necessità la forza e l’efficacia di una simile misura? Ed è proprio sotto questo aspetto, che l’eccezionale convenienza di un simile meccanismo emerge prepotente dall’anonimato di un catalogo antologico delle creature viventi. Ed è proprio in questa significativa ma poco studiata discendenza di artropodi predatori, fin da tempo immemore, che si tramanda il rarissimo segreto della riflettanza. Uno di quegli approcci alla soluzione di un problema tanto validi ed ingegnosi, come il fuoco, che noi siamo soliti affermare “Di sicuro, nulla più di questo può distinguere l’uomo dagli animali.” Ma non dovremmo certo sottovalutare ciò che nasce già specializzato in certi campi. Ed è stato equipaggiato, grazie al grande corso dell’evoluzione, per riuscire a regolare l’effettiva quantità di prede nel proprio legittimo bioma d’appartenenza.
Il che ci porta chiaramente al punto cardine della faccenda, così analizzato online, piuttosto che all’interno di aule polverose in qualche celebre università, direttamente nell’antico bosco a Singapore dall’esperto di macro-fotografia Nicky Bay, forse il primo ad osservare (e di sicuro a divulgare) una caratteristica notevole di questa vasta e variegata categoria di creature. All’interno del suo interessante articolo del 2013 Transformation of the Mirror Spider, corredato da una lunga serie di supporti visuali utili a dimostrare un significativo cambio di paradigma: la presa di coscienza che non soltanto un aracnide possa restituire la luce nella direzione di colui che osserva. Ma sia in grado di decidere di volta in volta se è il caso di farlo, ed in che misura…
organismi
“È soltanto una fase” dicevano. Ma un assolotto non può scegliere di essere salamandra
Alla ricezione di un segnale cronologicamente ineluttabile, la parte del cervello nota come ipofisi comincia ad operare il compito per cui è stata inclusa all’interno dell’organismo umano. Secernendo ormoni, stimola le gonadi, trasformando la funzione degli organi riproduttivi posseduti da entrambi i sessi, mentre il corpo dell’uomo si ricopre di peli e riempie di muscoli, la donna vede svilupparsi il bacino ed il seno. Il momento della pubertà rappresenta, sostanzialmente la perfetta metamorfosi, senza l’utilizzo di alcun bozzolo e soltanto lati positivi per il proseguire della propria esistenza. Ecco perché dal punto di vista del bipede sapiens, non c’è alcun tipo di ragione per ritardare o rinunciare a un simile processo. Pensate invece a un bruco, che spiegando le sue ali sa di essere entrato nell’ultima stagione della sua esistenza, essendo rimasto talvolta persino privo degli organi necessari a continuare a nutrirsi. Se quest’ultimo potesse rinunciare a un tale “onore”, potendo nonostante ciò dare un proseguo alla propria specie, pensate davvero che l’evoluzione avrebbe impedito quel cambiamento? Ciò di cui stiamo parlando prende il nome essenzialmente di neotenia, e consiste nel raggiungimento della maturità sessuale mantenendo nel contempo alcuni tratti esteriori, o caratteri biologici tipici dell’età infantile. Tale aspetto è presente nell’uomo soltanto in alcune caratteristiche, salvo malformazioni individuali, quali l’abilità di digerire il latte anche successivamente alla stagione in cui raggiunge l’età adulta. Ma c’è almeno una creatura, in Messico, che può dirsi l’effettivo Peter Pan del mondo naturale, assolutamente abituata a mantenersi giovane nel corpo e nella mente, per l’intera lunga durata dei 15 anni della propria esistenza. Molto superiore a quella di qualsiasi altra salamandra appartenente alla sua stessa famiglia.
Ambystoma mexicanum o più comunemente axolotl (assolotto) dall’appellativo del dio del fuoco e del fulmine secondo gli Aztechi, protettore dei mostri e dei gemelli, che si narra essersi trasformato in una di queste creature allo scopo di sottrarsi al sacrificio collettivo degli esseri superni, reso necessario dalla necessità di dare inizio al quinto Grande Ciclo dell’esistenza. Non che questo, a quanto pare, sia risultato sufficiente a salvarlo. Benché un qualche ottimo presupposto di riuscire a farlo dovesse pur essere stato presente, data la straordinaria capacità di rigenerazione posseduta da questi animali ormai rimasti allo stato brado soltanto in un singolo lago in prossimità di Città del Messico, che qualora dovessero riportare ferite o infortuni, possono ricreare agevolmente arti, coda e addirittura organi complessi, quali occhi, cuore e sistema nervoso. Mentre in laboratorio si è scoperto come possono persino incorporare tali “parti” prelevate da un loro simile, le quali mantenute a contatto con il loro corpo riacquisteranno gradualmente il 100% della funzionalità. Un altro vantaggio, se vogliamo, del restare in bilico prima dell’attimo fatidico della trasformazione, quando i vecchi errori vengono dimenticati e tutto può tornare alle condizioni ideali di partenza. A meno che…
Quello che state vedendo nella foto di destra qui sopra è in effetti sempre un assolotto, ma che per un assoluto scherzo del destino, ha visto terminare il suo stato di grazia. E ad un segnale irresistibile, ha terminato di svilupparsi. Verso l’ottenimento di quella che può presentarsi unicamente come una vera e propria salamandra scavatrice (gen. Ambystoma) morfologicamente non dissimile dalla parente prossima A. tigrinum, però priva della caratteristica livrea che l’ha resa amata nei terrari di mezzo mondo, qui sostituita da un semplice color nero opaco. Una condizione abbastanza poco comune, nei fatti, da motivare un’approfondita documentazione degli eventi futuri, al fine di poter raggiungere un consenso per gli altri appassionati che dovessero trovarsi a dover gestire questo tipo di evento…
L’irreale proliferazione del verme che ramifica se stesso per procreare
Era l’estate del 1879 quando a bordo della nave della marina inglese HMS Challenger, a largo dell’arcipelago delle Filippine, il biologo marino scozzese William Carmichael McIntosh lanciò una forbita esclamazione all’indirizzo della bacinella d’acqua portata sul ponte, contenente gli ultimi esemplari a campione raccolti dalla squadra di marinai assegnata alle sue ricerche in materia d’invertebrati. Questo perché sotto la luce splendente di un sole tropicale, in mezzo a una sottile nebbiolina costituita da krill, minuscole meduse e larve d’organismi più grandi, continuava a contorcersi qualcosa d’assolutamente inusitato. Quello che gli era parso essere, di primo acchito, un groviglio di vermi policheti attorcigliati tra loro, in maniera ragionevolmente analoga alla gestalt quasi-demoniaca di un rat king, adesso rivelava il suo segreto in tutta l’eccezionale assurdità delle circostanze: una sola testa, molte code, molte code che ne avevano a loro volta delle altre. Ed occhi distribuiti liberalmente lungo l’estendersi di un tale corpo, costellato di setole del tutto simili alle zampe di un millepiedi. “Per Giove…” disse nuovamente lo studioso “Questi sono rami, anzi, stoloni!” Il primo ufficiale, che nel frattempo si era avvicinato per comprendere le ragioni del capannello di persone, lo guardò a questo punto perplesso, non comprendendo il termine botanico. “Intendo un ramo naturale che si dirama dalla gemma principale, generando a sua volta ulteriori diramazioni della pianta. Il verme sarebbe la pianta. E noi, da oggi, gli agricoltori.” Ma il singolo esemplare catalogato per la prima volta con il nome descrittivo di Syllis ramosa, convenientemente inserito in una delle più diversificate e variegate famiglie di anellidi sottomarini, non sarebbe sopravvissuto al lungo viaggio di ritorno verso l’Occidente, diventando per il mondo accademico una creatura leggendaria alla stregua dell’unicorno, la manticora o la coccatrice. Almeno finché nel 2006, presso la laguna di Darwin in territorio australiano, l’esimio collega ed erede professionale Christopher Glasby non spezzò a metà con fare indagatore una spugna porifera del genere Petrosia, facendo un’eccezionale scoperta. Una miriade di corpi, incanalati nelle cavità di filtrazione dell’acqua possedute dall’organismo sessile costellato di spicole calcaree, tutti riconducibili allo stesso punto di partenza o radice. Dal quale un grosso paio d’occhi tondi lo guardavano con fare indagatore, quasi sfidandolo a trovargli un nome. “Ti chiamerò… Ramisyllis multicaudata. Ma sappiamo molto bene entrambi, quello che sei davvero!”
Un verme polichete per sua generica natura non è in effetti altro che una creatura tubolare e longilinea tra i 3 mm ed i 14 cm che vive sul fondale di molti mari della Terra, in cui la ripetizione del singolo modulo permetterebbe, in linea di principio a ciascun singolo segmento di avere un cuore, uno stomaco, una bocca ed un cervello. Il che tende a verificarsi nella maggior parte dei casi quando le condizioni e la temperatura risultano essere perfettamente ideali, lanciando un segnale universale che conduce chiaramente alla riproduzione. Ora se c’è una sola cosa che sia possibile affermare su tale classe di creature, ed in modo particolare per quanto concerne la famiglia tassonomica dei Syllidae, è che essi possiedono una vasta quantità di metodi per moltiplicare se stessi, da quello relativamente semplice dell’epigamia o schizogamia, consistente in una metamorfosi delle proprie chete o setole mentre il corpo si appiattisce, acquisendo in tal modo le caratteristiche necessarie per iniziare a nuotare e sollevarsi quindi nella colonna sottomarina. Al fine, molto chiaramente, di trovare un proprio simile con cui convolare a gioiosa congiunzione dei reciproci gameti (sperma, ovuli o entrambi) per permettere a ciascuno di mettere al mondo una nutrita quanto microscopica prole. Ma esiste anche il caso, e si tratta di un’eventualità piuttosto frequente, in cui specifiche varietà di questa categoria abbiano implementato, nel corso della loro evoluzione, un sistema per prevenire il rischio di una simile manovra, capace di renderli dei bersagli particolarmente invitanti per la fame insaziabile dei pesci ed altri predatori, tra cui l’uomo stesso. Il che sembrerebbe aver dato i natali, attraverso i lunghi secoli e millenni, alla particolare trasformazione nota come epitochia, consistente nel suddividere se stessi. Ed inviare parti analoghe di tale formula vincente a fare ciò da cui il corpo centrale, per ovvie ragioni, preferirebbe mantenersi a una ragionevole distanza di sicurezza…
Il segreto della vita nella valle della morte cilena
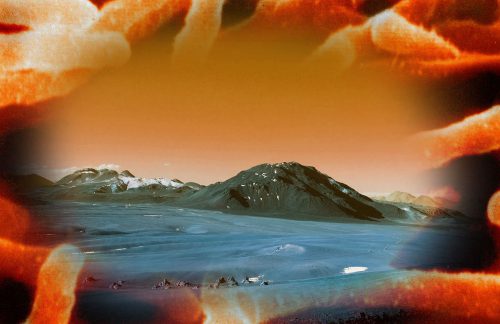
Essere privo di mente, senza occhi e senza orecchie, rimasto eternamente solo sopra il suolo arido di Marte. E con ciò voglio dire che il concetto d’individuo, ormai da tempo immemore, è per esso privo di significato, mentre ciascuna singola occorrenza della propria specie esiste in una sola monade continuativa, costituita dall’insieme plurimo dei suoi invisibili rappresentanti. Perché è questo il solo metodo, con cui i batteri possono riuscire a sopravvivere: mediante sforzo unico e totalizzante, di ogni microgrammo dell’enfatica biomassa, nella costruzione di un muro. La membrana cellulare che al confine delle cellule dei procarioti, ne difende il denso contenuto, d’acido desossiribonucleico, i mitocondri e tutto il resto, dalla polvere, dal Sole, dal pH della sabbia e dai protisti predatori. Ma non c’è nulla, in senso totalmente letterale, che potesse prepararli a questo: la calata di un lontanissimo parente, nei fatti più simile ad un fungo. Ed una profezia. Dell’orribile actinomicete (ord. Actinomycetales) creatura estremamente pervasiva grazie alle sue spore, che calando sopra il mucchio, ne inizia l’opera di distruzione sistematica. Diffondendo, a macchia d’olio, l’arma biologica più efficace di cui dispone; il feroce glicopeptide, che ogni membrana rende permeabile, smontandola sin dal più minuscolo mattone.
Una scena, questa, che potremmo facilmente rivedere (si fa per dire) altrove. Ovvero molto più vicino del pianeta Rosso ormai sempre più prossimo all’esplorazione umana, proprio qui nel nostro globo di terra ed acqua, presso il luogo che più d’ogni altro riesce a ricordarlo. Sudamerica, Cile, deserto dell’Atacama: terra super-secca grazie alla collocazione tra due alte catene montuose, le Ande e la Cordigliera della Costa, nonché battuto dal feroce anticiclone del Pacifico, capace a poche ore di distanza di far bollire le ossa o ghiacciare l’acqua all’interno di una bottiglia nel giro di pochissimi istanti. Un ambiente, insomma, che potremmo definire totalmente all’opposto della Vita per come siamo abituati a concepirla. Se non fosse, per citare lo scienziato sottovalutato di una celebre vicenda letteraria e cinematografica che “[Essa] trova, sempre, il modo.” Nelle crepe della terra ferita dalla luce ultravioletta, sotto sassi abbandonati a lato del sentiero, dentro buche impresse nel paesaggio da preistorici animali… E che maniera, quale splendido sistema di sopravvivenza!
Era l’anno 2008 quando un intero team di scienziati guidati dal biologo scozzese dell’Università di Newcastle Michael Goodfellow, si recò ad effettuare una ricerca che avrebbe cambiato per sempre la cognizione che avevamo di un simile luogo. Per l’isolamento sistematico, e tassonomico, dell’intera potenziale popolazione di queste creature largamente prive di studi pregressi, proprio per la natura inospitale e irraggiungibile del loro habitat d’appartenenza. Ciò che sostanzialmente nessuno, tra i diretti interessati e nell’intero mondo accademico riusciva tuttavia ad immaginarsi, fu a quel punto pura ed innegabile realtà: ecco proprio lì, nel luogo degli scheletri e del sale, una lista senza fine di creature totalmente nuove, ovvero appartenenti a specie prive di un nome e che tali sarebbero rimaste, a causa della propria incalcolabile ed imprevista varietà. Ma la parte forse più intrigante si sarebbe palesata successivamente, tra le mura sterili di un laboratorio. Dove il frutto di un così ricco raccolto, mescolato con intento sperimentale a batteri di provenienza più convenzionale, iniziò a produrre tutto attorno un’alone perfettamente circolare. Ebbene si: gli actinobatteri si stavano facendo largo nelle moltitudini, plasmando il proprio spazio come fatto da un coltello incandescente in un panetto di burro. Una strage senza nessun senso, tranne l’ira di chi vuole vendicarsi dei catturatori…




