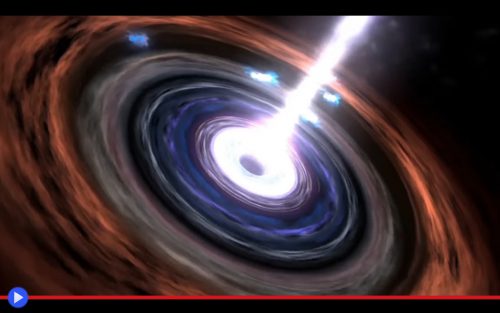Uomini che si colpiscono da soli, colpiscono gli altri ripetutamente, con calci, pugni e staffilate. Con massima concentrazione di forza ed apparente odio formale per la parte delicata della loro più profonda intimità: più e più volte, finché le loro grida di battaglia non diventino più acute ed intense, profondamente convinti nell’esercizio di auto-abnegazione che conduce con certezza all’immortalità in combattimento. Dovete considerare come nella disciplina delle scienze cinesi tradizionali, a differenza della visione usata in Occidente, il numero interpretativo per eccellenza non è il quattro, bensì quello che viene dopo. Vi sono cinque direzioni cardinali (nord, est, sud, ovest, centro) cinque elementi (legno, fuoco, terra, metallo, acqua) cinque note musicali, cinque agenti del cambiamento, cinque grandi filosofi, cinque momenti estemporanei nel semplice portare a termine un singolo respiro. E cinque punti preferibili per concentrarlo, di cui il più fondamentale il cuore. Ora, dal punto di vista dello studio finalizzato all’accrescimento del potenziale umano, il cuore può trovarsi in molti punti differenti. Persino nella mente. La teoria secondo cui gli esseri umani userebbero soltanto una minima parte del loro cervello, tuttavia, è stata più volte scientificamente smentita: tutto ciò che occorre è una scansione della calotta cranica, per osservare come basti la benché minima sollecitazione, affinché una grande varietà di neuroni, disseminati nei più remoti recessi di entrambi gli emisferi, producano la complessa combinazione di cariche elettriche che noi amiamo definire “pensiero”. Nell’opinione della maggior parte dei maestri d’arti marziali, dunque, il punto più importante del corpo umano è il dāntián 丹田 (o dantien) punto sito nell’addome e baricentro effettivo di ogni tipo di movimento del corpo umano. Luogo da cui trarrebbe l’origine il flusso del Qì 氣, lo spirito, per irrorare tutte le membra e arrecargli il dono del movimento vitale. Esiste tuttavia una scuola parallela, di cui si parla molto meno spesso, secondo cui la chiave per raggiungere uno stato superiore dell’esistenza sarebbe focalizzare la propria attenzione non su questo punto sopravvalutato della propria fisicità, bensì poco più in basso. In corrispondenza dei genitali.
Ciò ha una precisa ragione evolutiva, chiaramente comprensibile grazie all’uso della pura logica: cos’è per la natura dopo tutto un essere vivente, se non il veicolo per la propria stessa riproduzione? E nulla più, purtroppo… Nella maggior parte delle specie animali sottoposte all’osservazione degli etologi, la senescenza inizia a manifestarsi nel momento stesso in cui cessa la capacità di procreare. In nessun animale questo è più evidente che nel dramma dei salmoni, che periscono en masse pochi minuti dopo l’attimo della suprema frenesia. Mentre le grandi tartarughe di terra, vivendo a un ritmo rallentato, possono fare figli fino all’età di 80, 90, 100 anni. E proprio per questo, riescono a osservare con sguardo clinico anche svariate generazioni umane. Nel Kung Fu di Shaolin, quella poderosa collezione di tecniche ed idee che seppe trasformarsi, nei secoli, in un polo di riferimento su scala globale dei più alti picchi raggiunti (in tutti i sensi immaginabili) dalle discipline più o meno segrete delle arti marziali d’Oriente, l’imitazione delle qualità animali è uno dei fondamenti stessi della Verità. A tal proposito, vi siete mai chiesti perché mai una comunità di monaci buddhisti derivati dalla disciplina dell’eremita Bodhidarma, dediti per dogma all’importanza della non-violenza, abbia dedicato la propria stessa esistenza alla produzione di una classe guerriera letteralmente invincibile in battaglia, sia nel combattimento a mani nude che quello effettuato mediante l’uso di spietate armi? La risposta è che una simile potenza, per loro, non nacque da principio a seguito di una ricerca intenzionale. Essa derivò, semplicemente, dallo strumento filosofico della meditazione. Persino adesso, se voi stessi decideste di svuotare del tutto la mente, ed iniziaste a concentrarvi sul nulla (che poi altro non sarebbe, che il tutto) in breve tempo iniziereste a percepire il ritmo del vostro stesso respiro. Lentamente, gradualmente, iniziereste a controllarlo in modo conscio, ovvero, per usare un termine stereotipato, manuale. Ecco: è proprio questo che significa, utilizzare a pieno il potere della propria mente.
Fatelo per almeno due ore al giorno, da principio. Fatelo per otto, una volta acquisita sufficiente pratica, quindi 12 e ancor di più. Fatelo mentre poggiate i piedi in equilibrio sopra quattro uova di gallina, senza romperle, grazie all’innata leggiadria riconquistata della vostra fisicità. Fatelo sotto lo scroscio di un’eterna cascata, che ricada con tutto il suo peso sulle vostre spalle, diventate rigide come la pietra. Quindi, una volta raggiunto il controllo della gemma segreta che è nascosta nel vostro corpo, dirigetene il potere nella punta delle vostre dita. Ecco, ora esse sono pure e limpide come il diamante. Esse distruggeranno il velo dell’illusione. Nessun avversario potrà mai riuscire a resistergli. purché egli non possegga lo strumento di una tecnica perfettamente contrapposta. Perché un calcio nelle palle, resta pur sempre un calcio nelle palle. A meno che…