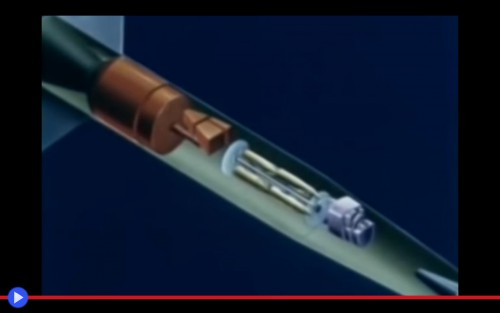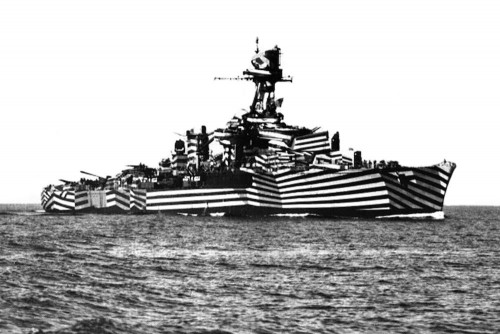Nell’antichità tutti i metodi per uccidere erano, come si usa dire, bianchi. Con punta di lancia, con taglio di lama, con testa di ascia, si tentava di uccidere il proprio nemico. Ed era una cosa orribile, senz’altro, esattamente come adesso. Eppure c’era un senso latente d’eleganza, dovuto all’inerente responsabilità necessaria per un gesto che non era facile da compiere, soprattutto in mezzo al caos di un capo di battaglia. E ciascuna delle armi utilizzate, a suo modo, era magnifica. Leggiadra ed affilata, saettante come il capo di un serpente, con aculei come spine di una rosa. Tentare di trafiggere qualcuno scagliando via la propria spada, ai tempi del Codice dei Cavalieri, sarebbe stato un gesto non soltanto privo di senso, ma disonorevole ed irrispettoso, verso i molti secoli di sapienza artigiana che essa racchiudeva, per non parlare della potenziale eredità del proprio genitore in armi, che con questo oggetto trasferiva lo status della propria intera classe sociale. Erano costoro, guerrieri per vocazione, ma mai veri professionisti della morte. Poi col proseguire delle epoche, l’invenzione della polvere da sparo non fece che rinforzare la questione: perché l’archibugio, il moschetto, e infine, il fucile con la canna rigata, non entravano mai in contatto con la carne del morituro, limitandosi a proiettare al suo indirizzo schegge di metallo acuminate, ciascuna concepita per un singolo, sgradevole utilizzo. Poi gettata via, nella discarica dei proiettili sparati. Presto nacque un vero e proprio culto, che ha tutt’ora fin troppi proseliti proseliti, mirato a venerare l’arma da fuoco come massimo traguardo superato dall’umanità, uno strumento totalmente demoniaco e dunque, senza alcun dubbio, infuso di quella scintilla sacrale di divinità. Armi che donano la morte, la producono, la smerciano, persino. E che per farlo, necessariamente, devono incorporarla al loro interno, in qualche forma o definizione.
Ma venne infine un giorno in cui qualcuno giunse a chiedersi: “Sarebbe possibile costruire uno strumento, presente o futuro, che al suo interno racchiuda la Mietitrice in persona?” Al punto che il solo vederlo potesse porre fine all’esistenza di qualcuno, come pure l’udirlo, il nominarlo, o addirittura la sua mera concezione sopra i tavoli progettuali, bastasse a mettere in pericolo l’intera dormiente umanità… Era il primo gennaio 1957 quando una commissione formata dalle Forze Aeree Statunitensi e l’Ente per l’Energia Atomica scelse d’interrogare il laboratorio Lawrence di Berkeley sulla questione, ottenendo la risposta che Si, teoricamente, la potenza dell’atomo poteva essere usata per far volare un missile intercontinentale. Anche se sarebbe stato, naturalmente, molto rischioso. Ciò perché un nocciolo a fusione, per sua stessa implicita natura, era un ricettacolo di pericolose particelle alfa e beta, lanciate in ogni direzione e in grado di distruggere facilmente l’organismo umano. E proprio per questo, una simile creazione necessitava di uno spesso scudo protettivo, simile a quelli usati per i reattori commerciali, o in misura minore, montati tra il motore e l’area calpestabile dei sottomarini a propulsione radioattiva. Ma come avresti mai potuto tu, inteso come progettista o ingegnere aerospaziale, incorporare un tale pesante meccanismo su di un arma fatta per attraversare i continenti, ad una velocità diverse volte superiore a quella del suono? La risposta fu veramente semplice: è completamente inutile preoccuparsene. All’epoca tutti sapevano, fin troppo bene, che cosa avrebbe comportato premere quel tasto rosso dell’Apocalisse. Ed a quel punto, che differenza avrebbero mai fatto qualche centinaio di sievert in più nell’atmosfera totalmente ionizzata… Un piccolo prezzo da pagare, in cambio della capacità irrinunciabile di Realizzare Cose Straordinarie. Perché un dispositivo dotato di carburante a resa tanto elevata, avrebbe potuto volare letteralmente per settimane, giungendo a compiere il giro della Terra per ben tre volte. Inoltre, sarebbe stato lungo 25 metri, e avrebbe potuto incorporare un sistema di guida radar basato sull’elevazione del territorio sottostante, estremamente avanzato per l’epoca, che i progettisti americani avevano definito TERCOM (Terrain Contour Matching). Tali caratteristiche gli avrebbero permesso, una volta in volo, di percorrere un complesso itinerario predefinito a bassa quota per schivare i radar, sopra le principali città ed installazioni militari dell’URSS, rilasciando per un certo numero di volte degli ordigni da fino a un megatone di potenza. Ne erano state proposte fino a una ventina. Continuando a spargere nel frattempo i suoi veleni, e causando danni incalcolabili per il continuo superamento della barriera del suono ad appena qualche centinaio di metri dal suolo. E alquanto incredibilmente, non finiva certamente qui.