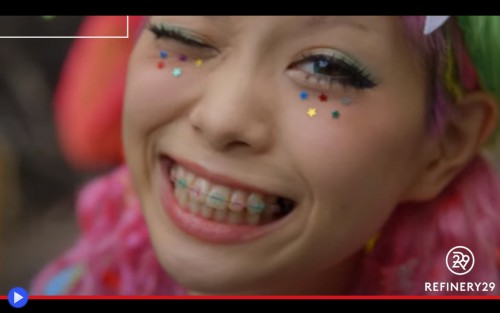Nel nuovo video dell’animatore russo trentaseienne Alexey Zakharov, anche noto come Seccovan, c’è un inizio molto particolare: una manciata di foto scattate durante tutta la prima metà del XX secolo vengono sollevate da una qualche forza invisibile, e attentamente depositate all’interno di quello che può soltanto essere definito un album steampunk. Ma come fa, potreste chiedervi a questo punto, un semplice libretto rilegato per dagherrotipi, ad essere effettivamente conforme a quel canone letterario che nacque all’inizio degli anni ’80, nel quale l’estetica di certi romanzi vittoriani, per non parlare della loro ambientazione cronologica e tanto spesso londinese, si mescola alla fantascienza più sfrenata in un tripudio di anacronistico divertissement? Bé… Il segreto è sopratutto nella copertina. In questo caso fittizia e creata rigorosamente al computer, ma con soluzioni grafiche che mirano a ricordare l’aspetto del metallo ribattuto, quindi ricoperto d’insensate valvole, ingranaggi, borchie dall’utilità improbabile ed addirittura un piccolo grammofono, incluso per impreziosire l’esperienza aurale di chiunque scelga di sfogliare un simile oggetto misterioso. E poi, naturalmente, un contatore meccanico con la data, come dall’esempio di un’importane precursore contestuale di questo genere, la macchina al centro romanzo La macchina del tempo di H.G. Wells (1895) in cui l’intraprendente scienziato Senza Nome, protagonista dell’intera vicenda, finiva per tornare da un futuro distopico ed alquanto derelitto. Mentre ai nostri tempi più che mai legati ad un contesto realistico e vicino, uno strumento in grado di spostarsi lungo l’asse dei mesi e degli anni, non può che trovarsi al servizio di uno scopo ben più nobile e per certi versi, affascinante: conoscere direttamente l’epoca dei nostri antenati. Con lo scopo di comprendere come siamo giunti fino a questo punto e, se possibile, non fare i loro stessi errori. Ma questo che si trova innanzi a noi, persino nella finzione del creativo che l’ha disegnato, è soltanto un piccolo marchingegno. Di quelli in cui difficilmente potrebbe entrare una cavia inviata nel senato di Roma per assistere alle Idi di Marzo, o uno scimpanzé destinato a seguire Napoleone durante il suo sfortunato attacco a Hougoumont. Tutto quello che può fare, è alterare chimicamente o in modo quantistico le microparticelle che costituiscono le immagini portate alla nostra attenzione. Per riportare a tutti gli effetti, le figure, gli scenari, le inquadrature, all’epoca dei nostri nonni, quando furono materialmente impresse su pellicola. Ed è una visione…Estremamente affascinante.
Tutto ebbe inizio, ha raccontato Zakharov al Daily Mail, circa un annetto fa, quando l’artista ebbe modo di conoscere più approfonditamente il blog fotografico Shorpy, intitolato a un minatore dell’Alabama deceduto in uno sfortunato incidente del 1928, all’interno del quale uno o più autori anonimi inseriscono innumerevoli foto dell’epoca moderna americana, molto spesso restaurate per le nuove generazioni. In quel caso, lui ne aveva scelta una da animare con la tecnica del projection mapping, che consiste nel ritagliarne virtualmente i singoli elementi per creare un vago effetto tridimensionale, riuscendo a creare un qualcosa che subito trovò meraviglioso. Così decise che prima o poi, o comunque non appena avesse trovato il tempo, da quel punto di partenza avrebbe dato origine ad un intero Progetto, completo in ogni sua parte e pronto a prendere d’assalto la fantasia del vasto web. Che è stato finalmente rilasciato al pubblico soltanto due settimane fa, col titolo altamente suggestivo e vagamente citazionistico di The Old New World (Il vecchio nuovo mondo). Per il quale, a tale tecnica informatizzata sono state sottoposte oltre una decina di fotografie delle prime due decadi del secolo scorso, scattate nei contesti più diversi tra le città di New York, Washington D.C, Boston, Detroit e niente meno che Wilmerding, Pennsylvania, cittadina famosa più che altro per un’importante compagnia produttrice di freni ferroviari, la Westinghouse Air Brake Company. Ma oltre che fornire spessore a queste immagini, l’autore ha scelto di fare il passo ulteriore nel suo fantastico viaggio nel tempo: gli ha ridato, letteralmente, la vita…