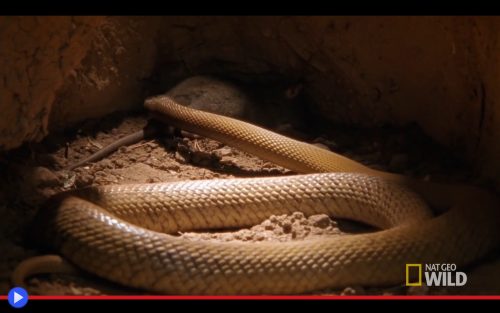Il 15 settembre del 1967 in Australia, una guida turistica nota unicamente come Mr. C. decise impropriamente di fare qualcosa di affascinante per il suo gruppo in visita a Channel Country. Avendo scorto un’ombra in mezzo all’erba rada del bush, si avvicinò di soppiatto alla figura lunga quasi due metri di un serpente. E tentando di afferrarlo, finì suo malgrado per essere morso a una caviglia. Una contingenza molto sconsigliabile dato il colore marrone e le scaglie romboidali dell’impressionante creatura, sufficienti ad identificarli come un rappresentante altamente velenoso dei taipan (gen. Oxyuranus). Quello che costui, nessuno dei presenti e neanche i medici dell’Elizabeth Hospital, dove sarebbe stato trasportato d’urgenza in eliambulanza potevano inizialmente sapere tuttavia, era che l’effettiva specie dell’animale ucciso e prelevato dai presenti sarebbe stato in seguito identificato retroattivamente come un qualcosa di assolutamente “speciale”. Un rettile la cui odierna qualifica come singolo strisciante dal veleno più potente al mondo avrebbe necessariamente suscitato in Mr. C. una considerevole, ed ulteriore dose di pessimismo. Ciononostante, pur mostrando i sintomi temporanei di una myasthenia gravis con paralisi dei muscoli facciali e difficoltà respiratorie per due settimane, sintomi aggravati dall’impossibilità di somministrare un siero a causa di reazioni allergiche pregresse, egli sarebbe stato infine dimesso per sua fortuna potendo ritornare alla vita di prima. Con un rinnovata, salubre rispetto nei confronti dei serpenti australiani. Soltanto anni dopo, inviando l’esemplare preservato presso l’occhio scrutatore del naturalista Eric Worrell, sarebbe stata infine negata la sua originale qualifica come O. scutellatus o taipan costiero, associandolo piuttosto alla specie ormai quasi dimenticata dell’O. microlepidotus o taipan dell’entroterra, non più avvistato dopo la sua prima descrizione scientifica nel 1879. Una creatura destinata ad incontrare il soprannome di fierce snake (serp. feroce) non tanto in funzione del suo temperamento bensì la straordinaria pericolosità del suo armamento chimico, contenente un cocktail estremamente complesso di tossine in grado di attaccare nel contempo muscoli, sangue e sistema nervoso, con dolori lancinanti, paralisi, danno agli organi ed un rischio elevato di coaguli potenzialmente letali. Caratteristica affine a quella delle altre due specie esistenti di taipan (la terza scoperta nel 2007) ma in questo caso aggravato dalle dimensioni del portatore e le sue affinate strategie di caccia, che prevedono un’alta quantità di morsi portati a segno in un singolo attacco e grandi quantità di veleno iniettate ogni singola volta. Un approccio d’uccisione attentamente calibrato sulla necessità di sopravvivere in un ambiente tanto inospitale e dalle temperature così elevate come l’entroterra del continente meridionale, dove le ore utili alla caccia sono limitate all’alba e al tramonto, mentre le prede principali disponibili includono topi, bandicoot e le varie specie di ratti nativi del bush. Esseri la cui cattura non è sempre facile, o priva di pericoli come si potrebbe tendere a pensare…
L’osservazione di un taipan feroce in caccia, oggi possibile dopo la ritrovata identificazione di ampie popolazioni nel corso degli anni ’70 ad opera tra gli altri di Jeanette Covacevich, erpetologa del Museo del Queensland, mostra tutte le caratteristiche di un vero e proprio mostro d’agilità e sveltezza. Capace di muoversi agevolmente nelle buche o asperità del terreno, balzando in avanti, mordendo la preda e avviluppandole nelle sue spire, approccio rischioso in altre circostanze, ma che può contare in questo caso sull’effetto mostruosamente rapido della sostanza inoculata nelle prime fasi della battaglia. Accampando ipotesi sul perché esattamente l’O. scutellatus possieda tossine a tal punto potenti, si è giunti a collegarle tra le altre cose alla necessità da parte di quest’ultimo di poter uccidere anche dopo aver svuotato recentemente le proprie ghiandole, nella maniera in cui può capitare successivamente ad episodi d’autodifesa, particolarmente nei confronti di animali non-nativi come gatti, volpi o cani. Diffuso principalmente nelle zone di Diamantina, Morney Plains Station ed il Parco Nazionale di Astrebla Downs, oltre al distretto di Marree-Innamincka nell’Australia Meridionale, con una popolazione isolata nelle vicinanze della famosa città sotterranea di Coober Pedy, questa specifica varietà di taipan risulta maggiormente facile da identificare all’apice dell’estate, quando il colore delle sue scaglie si schiarisce virando verso l’arancione ed il giallo, un espediente naturale finalizzato a migliorare la capacità di dissipare il calore eccessivamente intenso. Il suo stato di conservazione, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare data la lunga mancanza di avvistamenti, risulta essere in realtà piuttosto buono nel suo complesso, benché la riduzione dell’habitat abbia portato la specie a scomparire in epoca presumibilmente recente dagli stati del Nuovo Galles del Sud e Victoria. Il che non è del tutto o necessariamente un male, visto l’elevatissimo grado di pericolosità nei confronti dell’uomo, mitigato unicamente dall’areale particolarmente remoto dove abitano le maggiori concentrazioni di questo vero e proprio mostro della natura. In caso di morso, spesso causato da un’impropria quanto sconsigliabile insistenza in prossimità di un esemplare, tipicamente incline a ritirarsi o evitare il confronto, esistono due trattamenti possibili. Quello preferibile è un siero polivalente contro l’avvelenamento da taipan, creato a costo della vita dell’estrattore del veleno Kevin Budden, morso letalmente all’interno del proprio laboratorio amatoriale nel 1950. Mentre un secondo a base di anticorpi equini e dall’effetto polivalente può talvolta sortire l’effetto desiderato, mitigando almeno i sintomi affinché sia possibile effettuare un trattamento. Ciò detto, nella maggior parte dei casi di morsi identificati correttamente e tempestivamente come opera dell’O. scutellatus la sopravvivenza risulta possibile, nella maniera dimostrata nelle ultime due volte a beneficio di un ragazzo di Kurri Kurri morso dal suo serpente domestico illegale nel 2012, e il dimostratore/ammaestratore di bestie selvatiche Scott Grant, che si stava esibendo nel 2013 di fronte a un pubblico di 300 persone.
I quali restano, più che altro, dei casi limiti particolarmente “fortunati”. Vista la collocazione remota e difficilmente raggiungibile in tempo utile della maggior parte delle situazioni in cui si può venire morsi da un taipan di siffatta natura, potenzialmente al di fuori della portata di un qualsivoglia elisoccorso. Anche ammesso e non concesso che sia possibile identificare tempestivamente l’origine della ferita, dove non sempre viene lasciata dai primi soccorritori una sufficiente quantità di veleno utilizzabile al fine di risalire alla specie dell’aggressore. Mentre nel caso in cui il bersaglio sia un escursionista solitario, come può essere ragionevolmente capitato più volte nel corso delle ultime decadi, le possibilità di sopravvivere si avvicinano pericolosamente allo zero.
È il rischio che deriva dall’area geografica, se vogliamo, ove striscia una creatura che i millenni hanno preparato a dar la caccia in modo particolare ad una singola tipologia di prede, creando il cocktail perfetto per l’uccisione dei mammiferi e soltanto quelli. D’altra parte una certa somiglianza biologica coi topi, lo sappiamo fin troppo bene, risulta da tempo alla base di ampi settori di ricerca all’interno di molteplici laboratori. Per la legge di un karma che dimostra, tanto spesso, placide tendenze all’assassinio.