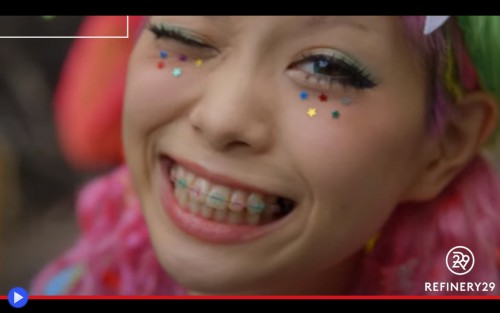Se Parigi è la città delle luci, e Roma quella eterna, è mai possibile che tutti gli altri luoghi debbano soltanto essere comparati a loro? Non c’è un solo agglomerato urbano, tra Oriente ed Occidente, in cui il concetto di eleganza ed opulenza vengano espressi in miglior modo dalle antiche mura, dai luoghi si svago e d’incontro e dallo stesso sguardo della gente, i cui occhi si soffermano soltanto per pochi attimi su meraviglie senza limiti né tempo. O almeno, così dicono i turisti, americani, russi, cinesi e giapponesi, che dai nostri luoghi tornano con un ricordo straordinario e significativo, la guida turistica piena di segnalibri ed in genere, almeno un souvenir o due. Ciò detto; anche la grande capitale da cui s’irradiano le mode e le tendenze dell’intero arcipelago nipponico, nel mezzo dell’isola dello Honshu, ha il suo fascino immanente e duraturo, creato dalla mescolanza tra il moderno e la tradizione, ovvero quello spazio condiviso tra gli antichi templi e i centri commerciali, le automobili e le geisha, le katana ed i kimono. Così perfettamente esemplificato, per antonomasia condivisa in forza dei diffusi preconcetti, da quel patinato e irrinunciabile quartiere, la zona commerciale che prende il nome di Ginza… Di fronte al quale, un tempo, c’era il mare. E invece adesso scorre un semplice canale. Oltre le cui acque, fin dal remoto 1894, sorge una gran zolla in terra reclamata, fatta sorgere artificialmente per proteggere l’approdo della imbarcazioni. La chiamano Tsukishima, ovvero letteralmente: l’Isola della Luna. Su quest’isola vive un vecchio signore. Con la sua splendida e imponente tartaruga.
C’era del resto, pure la leggenda. Un racconto così insito nella natura umana, che lo ritroviamo in molte forme e versioni attraverso tutto il territorio del paese, e addirittura, totalmente ricreato altrove, con personaggi diversi ma lo stesso identico messaggio. Mukashi mukashi (tanto tempo fa) si narra che un pescatore molto povero di nome Urashima Tarō viveva nel villaggio di Midzunoe (dove?!) Egli amava lanciarsi in lunghe esplorazioni con la sua barchetta, e se soltanto avesse avuto le risorse finanziarie, già da tempo avrebbe scelto di partire per una grande avventura. Ma le giornate procedevano monotone, e sempre uguali tra di loro. Finché un giorno, all’improvviso, non si ritrovò al cospetto di un piccolo rettile col carapace, che di certo aveva trascorso tempi migliori. Secondo alcune tradizioni, la tartaruga stava subendo le angherie di un gruppo di bambini, che doverosamente Tarō scacciò via. In altre invece, fu lui a pescarla per errore, decidendo subito di liberarla per accumulare un karma positivo. Fatto sta che l’animale venne rigettato in acqua, e subito sparì. Il giorno dopo quindi, mentre il pescatore si preparava per la sua uscita mattutina, una gigantesca tartaruga giunse fino a riva, aprì la bocca e parlò: “Oh. Abitante della terra ferma. Sappi che colei che tu hai aiutato ieri, non era un semplice abitante dell’Oceano. Ma la figlia stessa di Ryūjin, il Dio Drago che comanda tutte le acque del mondo. Egli vorrebbe, dunque ringraziarti di persona. Vuoi tu, seguirmi fino al suo palazzo?”
Ora naturalmente, le creature di cui parla questa fiaba non erano testuggini della terraferma, come la Geochelone sulcata di provenienza africana che il sessantaduenne proprietario di un’impresa di pompe funebri Hisao Mitani porta tutti i giorni a passeggiare, per un tempo di circa due e ore e mezza, lungo un itinerario che li porta da Tsukishima a Ginza, e poi di nuovo fino a casa. Ma terra e mare, quale mai è la differenza? Di certo, non ci avrebbe fatto caso il pescatore. Né tanto meno l’inventore della storia. O i bambini…